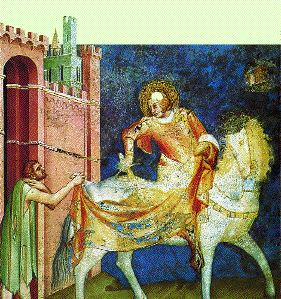di Stefano Tarocchi • La liturgia delle domeniche di questa estate ci mette di fronte ad una sezione importante dei Vangeli sinottici, quella detta delle parabole. Fra l’altro nella lingua italiana dal termine greco «parabola» deriva il nostro «parola».
di Stefano Tarocchi • La liturgia delle domeniche di questa estate ci mette di fronte ad una sezione importante dei Vangeli sinottici, quella detta delle parabole. Fra l’altro nella lingua italiana dal termine greco «parabola» deriva il nostro «parola».
Ora, secondo il dizionario della Treccani, la parabola è la «narrazione di un fatto immaginario ma appartenente alla vita reale, con il quale si vuole adombrare una verità o illustrare un insegnamento morale o religioso; nell’ebraismo rabbinico la parabola era molto comune nella predicazione e nell’insegnamento e fu questa appunto la forma originale dell’insegnamento di Gesù. Il termine è riferito oggi esclusivamente alle quarantanove contenute nei Vangeli sinottici».
Contemporaneamente, secondo la stessa fonte, l’allegoria (dal greco “parlare d’altro”) è una «figura retorica, per la quale si affida a una scrittura … un senso riposto e allusivo, diverso da quello che è il contenuto logico delle parole. Diversamente dalla metafora, la quale consiste in una parola, o tutt’al più in una frase, trasferita dal concetto a cui solitamente e propriamente si applica ad altro che abbia qualche somiglianza col primo, l’allegoria è il racconto di una azione che dev’essere interpretata diversamente dal suo significato apparente».
Così leggiamo nel vangelo di Marco, dopo che Gesù ha raccontato la parabola che apre il capitolo 4: «Quando furono da soli [con Gesù], quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici lo interrogavano sulle parabole. Ed egli diceva loro: «A voi è stato dato il mistero del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato». E disse loro: «Non capite questa parabola, e come potrete comprendere tutte le parabole?» (Mc 4,10-13). Qui ovviamente non è possibile affrontare tutta la complessa questione evocata dal racconto del vangelo secondo Marco, e poi confluita nei paralleli di Matteo e Luca. Vorrei invece opporre il racconto della parabola vera e propria alla sua riscrittura allegorica.
Cominciamo accostando la parabola del seme e del seminatore, così come si trova nello stesso vangelo di Marco: «Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. Insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: «Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; e subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto: spuntarono, crebbero e resero il trenta, il sessanta, il cento per uno». E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!» (Mc 4,1-9; cf. Mt 13,1-9; Lc 8,4-8).
Ed ecco quindi di seguito la sua narrazione allegorica, originata dall’interrogazione dei discepoli, che «lo interrogavano sulle parabole»: «il seminatore semina la Parola. Quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la Parola, ma, quando l’ascoltano, subito viene Satana e porta via la Parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che, quando ascoltano la Parola, subito l’accolgono con gioia, ma non hanno radice in sé stessi, sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della Parola, subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi: questi sono coloro che hanno ascoltato la Parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni, soffocano la Parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono: sono coloro che ascoltano la Parola, l’accolgono e portano frutto: il trenta, il sessanta, il cento per uno» (Mc 4,14-20; cf. Mt 13,18-23; Lc 8,11-15).
Gesù ha appena detto che ai discepoli, e ai Dodici, «è stato dato il mistero del regno di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, affinché guardino, sì, ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato» (Mc 4,11-12).
Il Vangelo riprende qui la parola del profeta Isaia, nel momento preciso della sua chiamata, quando davanti alla visione del Signore sul suo trono, circondato dai Serafini con sei ali ciascuno egli esclama: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e disse: «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato». Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!». Egli disse: «Va’ e riferisci a questo popolo: “Ascoltate pure, ma non comprenderete, osservate pure, ma non conoscerete”. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d’orecchio e acceca i suoi occhi, e non veda con gli occhi né oda con gli orecchi né comprenda con il cuore né si converta in modo da essere guarito» (Is 65,6-10).
La missione dell’uomo di Dio, ossia il profeta Isaia, che dovrà compiere la sua missione davanti alla sua apparente inutilità, viene trasportato all’interno del Vangelo: è Gesù che la continua.
Gesù narra del seme che ad una lettura superficiale viene gettato su suoli dalla natura differente, dovuta alla normale pratica di semina al tempo e nel luogo dove si compie la sua missione.
Questa è la parabola, che ha dunque un unico orizzonte di riferimento, dato dall’apparente vanità di una fatica, su terreni sassosi e spinosi, e sulla strada, compensata però dall’abbondanza più che straordinaria del raccolto sul terreno buono. E qui l’importanza è da collocarsi sul seme e sul seminatore: la parola che egli porta non si fa annientare da nessuna fragilità e debolezza umana: è la missione di Gesù in ogni tempo, che continua nella comunità dei credenti in lui, anche se apparentemente fallimentare.
L’allegoria che accompagna la parabola, nata anch’essa all’interno della prima generazione cristiana, si sposta su un orizzonte complementare: quello del terreno che accoglie la parola. Qui sono importanti i singoli dettagli, che infatti vengono puntualmente spiegati. Ora il terreno che la accoglie la parola è importante, ma non può fermarne la straordinaria fecondità. In altri termini, i credenti dovranno sforzarsi di diventare il terreno fecondo, quello buono, ma non potranno mai sostituire sé stessi all’azione divina che Gesù lascia come compito alla comunità dei suoi discepoli.
Il «mistero del regno di Dio», affidato ai discepoli, e in particolare ai Dodici, verrà rivelato pienamente solo alla fine dei tempi. L’azione di Gesù, prende atto dell’incomprensione delle sue parole per «quelli che sono fuori», e anche della possibile indolenza degli stessi discepoli.
In sostanza, questo «mistero» è stato nascosto mediante le parabole, non «per la loro oscurità e complicazione – come scrive un commentatore –, ma proprio per la loro semplicità…: il significato delle parabole si svela solamente a colui che capisce che hanno a che fare con il Messia Gesù». Con la venuta del suo Figlio, Dio ha stabilito che è ormai il tempo di ascoltare la sua parola. Come scrive san Paolo ai cristiani di Corinto: «Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!» (2 Cor 6,2).
 Andrea Drigani nel centenario della Lettera di Papa Benedetto XV ai Capi dei popoli belligeranti riflette sul ruolo del diritto internazionale per la promozione della pace nel mondo. Giovanni Campanella presenta il libro di Alessandra Del Boca e Antonietta Mundo che tratta il tema del rapporto tra il sistema pensionistico ed il mercato del lavoro. Dario Chiapetti introduce alla lettura di due saggi di Hans Urs von Balthasar, per la prima volta tradotti in italiano, al fine di contribuire alla comprensione della dimensione escatologica della teologia. Antonio Lovascio tenendo conto dei dati statistici richiama l’attenzione sul grave problema dell’occupazione giovanile che fa emergere, accanto alle immigrazioni, anche le nuove emigrazioni. Alessandro Clemenzia dalla recensione di alcuni studi sulla riforma ecclesiale dal Vaticano II a Papa Francesco, rileva che la molteplicità trova nell’unità la sua forma relazionale attuativa. Mario Alexis Portella nel ricordare la visita del Presidente USA Richard Nixon in Cina, che segnò l’inizio rapporti commerciali con l’Occidente, ma non della tutela dei diritti umani, illustra lo stato attuale delle relazioni tra la Santa Sede e la Cina. Francesco Vermigli in occasione della festa liturgica, il 9 agosto, di Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) ripropone il suo pensiero filosofico e teologico come antidoto alla crisi della civiltà occidentale. Carlo Parenti annota sulla recente pubblicazione del carteggio tra monsignor Loris Francesco Capovilla, segretario di Giovanni XXIII, e padre Davide Maria Turoldo, che costituisce un ulteriore contributo alla storia del cattolicesimo italiano del Novecento. Stefano Tarocchi per contribuire ad una maggiore comprensione dell’annuncio evangelico, si sofferma sulla distinzione e sulla correlazione tra «parabola» ed «allegoria». Gianni Cioli svolge alcune osservazioni su un Documento della Santa Sede, di qualche tempo fa, sulla tossicomania, che contiene però indicazioni di grande attualità sia per l’aspetto morale che per quello pedagogico. Leonardo Salutati da un messaggio di Papa Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali sull’ampliamento della nozione di giustizia, trae alcune conclusioni da applicare al sistema bancario e finanziario. Giovanni Pallanti dopo un viaggio nell’Italia Meridionale esprime delle considerazioni circa quell’ambito culturale e religioso. Stefano Liccioli commentando la lettera dei vescovi delle diocesi interessate al Cammino di Santiago, ripropone il senso teologale di ogni pellegrinaggio: la preghiera, il discernimento personale e la cura del proprio rapporto con Dio. Carlo Nardi ancora in compagnia di San Martino ci invita a tener sempre presente la verità e la difficoltà del rapporto tra la «potestas sacra» e l’«imperium».
Andrea Drigani nel centenario della Lettera di Papa Benedetto XV ai Capi dei popoli belligeranti riflette sul ruolo del diritto internazionale per la promozione della pace nel mondo. Giovanni Campanella presenta il libro di Alessandra Del Boca e Antonietta Mundo che tratta il tema del rapporto tra il sistema pensionistico ed il mercato del lavoro. Dario Chiapetti introduce alla lettura di due saggi di Hans Urs von Balthasar, per la prima volta tradotti in italiano, al fine di contribuire alla comprensione della dimensione escatologica della teologia. Antonio Lovascio tenendo conto dei dati statistici richiama l’attenzione sul grave problema dell’occupazione giovanile che fa emergere, accanto alle immigrazioni, anche le nuove emigrazioni. Alessandro Clemenzia dalla recensione di alcuni studi sulla riforma ecclesiale dal Vaticano II a Papa Francesco, rileva che la molteplicità trova nell’unità la sua forma relazionale attuativa. Mario Alexis Portella nel ricordare la visita del Presidente USA Richard Nixon in Cina, che segnò l’inizio rapporti commerciali con l’Occidente, ma non della tutela dei diritti umani, illustra lo stato attuale delle relazioni tra la Santa Sede e la Cina. Francesco Vermigli in occasione della festa liturgica, il 9 agosto, di Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) ripropone il suo pensiero filosofico e teologico come antidoto alla crisi della civiltà occidentale. Carlo Parenti annota sulla recente pubblicazione del carteggio tra monsignor Loris Francesco Capovilla, segretario di Giovanni XXIII, e padre Davide Maria Turoldo, che costituisce un ulteriore contributo alla storia del cattolicesimo italiano del Novecento. Stefano Tarocchi per contribuire ad una maggiore comprensione dell’annuncio evangelico, si sofferma sulla distinzione e sulla correlazione tra «parabola» ed «allegoria». Gianni Cioli svolge alcune osservazioni su un Documento della Santa Sede, di qualche tempo fa, sulla tossicomania, che contiene però indicazioni di grande attualità sia per l’aspetto morale che per quello pedagogico. Leonardo Salutati da un messaggio di Papa Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali sull’ampliamento della nozione di giustizia, trae alcune conclusioni da applicare al sistema bancario e finanziario. Giovanni Pallanti dopo un viaggio nell’Italia Meridionale esprime delle considerazioni circa quell’ambito culturale e religioso. Stefano Liccioli commentando la lettera dei vescovi delle diocesi interessate al Cammino di Santiago, ripropone il senso teologale di ogni pellegrinaggio: la preghiera, il discernimento personale e la cura del proprio rapporto con Dio. Carlo Nardi ancora in compagnia di San Martino ci invita a tener sempre presente la verità e la difficoltà del rapporto tra la «potestas sacra» e l’«imperium».