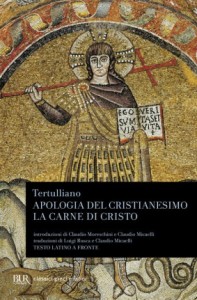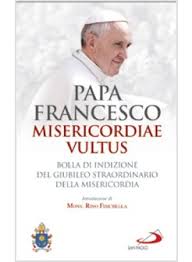Alcune sottolineature a partire dal sinodo sulla famiglia
 di Stefano Liccioli • «Da Gerusalemme la famiglia scendeva verso Gerico. Scendeva per le vie tortuose e impervie della storia quando, ad una svolta della strada, incontrò i Tempi Moderni. Non erano di natura loro briganti, non peggio di tanti altri Tempi, ma si accanirono subito contro la famiglia, non trovando di loro gusto la sua pace, che rispecchiava ancora la luce della città di Dio. Le rubarono prima di tutto la fede, che bene o male aveva conservato fino a quel momento come un fuoco acceso sotto la cenere dei secoli. Poi la spogliarono dell’unità e della fedeltà, della gioia dei figli e di ogni fecondità generosa; infine le tolsero la serenità del colloquio domestico, la solidarietà con il vicinato, l’ospitalità sacra per i viandanti e i dispersi. La lasciarono così semiviva sull’orlo della strada e se ne andarono. Passò per quella strada un sociologo, vide la famiglia, la studiò a lungo e disse: “Ormai è morta!” e andò oltre. La trovò un prete e si mise a sgridarla: “Dovevi opporti ai ladroni! Perché non hai resistito meglio? Eri forse d’accordo con chi ti calpestava?”. Le venne accanto uno psicologo e sentenziò: “L’istituzione familiare era oppressiva. Meglio così”. Passò alla fine il Signore, ne ebbe compassione e si chinò su di lei a curarne le ferite, versandovi sopra l’olio della sua tenerezza e il vino del suo sdegno. Poi, caricatala sulle spalle, la portò fino alla Chiesa e gliela affidò, perché ne avesse cura, dicendole: “Ho già pagato per lei tutto quello che c’era da pagare. L’ho comprata con il mio sangue e voglio farne la mia prima, piccola sposa. Non lasciarla più sola sulla strada, in balìa dei Tempi. Ristorala con la mia Parola e il mio Pane. Al mio ritorno ti chiederò conto di lei!” Quando si riebbe la famiglia ricordò il volto del Signore chino su di lei. Assaporò la gioia di quell’amore».
di Stefano Liccioli • «Da Gerusalemme la famiglia scendeva verso Gerico. Scendeva per le vie tortuose e impervie della storia quando, ad una svolta della strada, incontrò i Tempi Moderni. Non erano di natura loro briganti, non peggio di tanti altri Tempi, ma si accanirono subito contro la famiglia, non trovando di loro gusto la sua pace, che rispecchiava ancora la luce della città di Dio. Le rubarono prima di tutto la fede, che bene o male aveva conservato fino a quel momento come un fuoco acceso sotto la cenere dei secoli. Poi la spogliarono dell’unità e della fedeltà, della gioia dei figli e di ogni fecondità generosa; infine le tolsero la serenità del colloquio domestico, la solidarietà con il vicinato, l’ospitalità sacra per i viandanti e i dispersi. La lasciarono così semiviva sull’orlo della strada e se ne andarono. Passò per quella strada un sociologo, vide la famiglia, la studiò a lungo e disse: “Ormai è morta!” e andò oltre. La trovò un prete e si mise a sgridarla: “Dovevi opporti ai ladroni! Perché non hai resistito meglio? Eri forse d’accordo con chi ti calpestava?”. Le venne accanto uno psicologo e sentenziò: “L’istituzione familiare era oppressiva. Meglio così”. Passò alla fine il Signore, ne ebbe compassione e si chinò su di lei a curarne le ferite, versandovi sopra l’olio della sua tenerezza e il vino del suo sdegno. Poi, caricatala sulle spalle, la portò fino alla Chiesa e gliela affidò, perché ne avesse cura, dicendole: “Ho già pagato per lei tutto quello che c’era da pagare. L’ho comprata con il mio sangue e voglio farne la mia prima, piccola sposa. Non lasciarla più sola sulla strada, in balìa dei Tempi. Ristorala con la mia Parola e il mio Pane. Al mio ritorno ti chiederò conto di lei!” Quando si riebbe la famiglia ricordò il volto del Signore chino su di lei. Assaporò la gioia di quell’amore».
Ho trovato in Rete questa metafora sulla famiglia, una parabola nella parabola che mi sembra esprima bene quello che ha fatto la Chiesa in questi ultimi due anni, prima con il Sinodo straordinario e poi con quello ordinario: chinarsi sulla famiglia, sulle sue gioie e sulle sue ferite. Direi che uno dei risultati più importanti del Sinodo è il Sinodo stesso, questo ritrovarsi, intorno al Papa, di oltre duecentocinquanta esponenti di rilievo della Chiesa, tra cardinali, vescovi, esperti, sposi, a parlare di matrimonio, a riflettere su come rafforzare l’istituto familiare. Mi viene da domandare quale altra istituzione diffusa a livello mondiale impieghi tante energie per un obiettivo ritenuto così importante per il bene comune.
L’attenzione dei mass media spesso si è concentrata su quegli elementi di novità che potevano nascere dal Sinodo o sulle possibili lacerazioni e contrasti tra i padri sinodali, divisi arbitrariamente tra conservatori e progressisti. Non è questa la sede per un’analisi puntuale della relazione finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, ma guardando le votazioni dei singoli numeri della relazione emerge che sono stati approvati tutti con molti voti a favore. I numeri che hanno avuto più voti contrari (comunque meno di un terzo dei voti dei presenti) sono stati i nr 84, 85 e 86 riportati nel capitolo terzo, intitolato “Famiglia e accompagnamento spirituale”. Il tema è quello dei divorziati risposati che, secondo i padri sinodali, devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, «essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo». Nei nr 85 e 86 c’è un invito ai pastori a saper discernere le varie situazioni, ribadendo quanto afferma la Familiaris Consortio e cioé che «c’è differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido». In attesa di capire quale sarà la posizione del Santo Padre su questi ed altri argomenti, credo che attraverso il Sinodo la Chiesa abbia rilanciato al mondo la visione della famiglia come una buona notizia, qualcosa di appetibile e attraente ed il matrimonio come un’occasione per accogliere la proposta evangelica dell’amore per sempre.