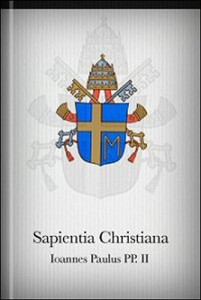di Stefano Tarocchi • È un fatto che il libro degli Atti utilizzi la strada di un triplice racconto per trasmettere ai suoi lettori quell’episodio chiave che cambiò definitivamente il cammino di Paolo di Tarso. Le altre narrazioni derivano dalle lettere, a cominciare dal racconto della lettera ai Galati, che usa lo stesso verbo perseguitare, che ritroviamo nelle parole di Gesù a Paolo sulla via di Damasco. Tra l’altro, Non possiamo dire con certezza che questo fatto – l’autorità del sommo sacerdote sulle comunità giudaiche al di fuori di Gerusalemme – sia storicamente provata, anche se un testo del primo libro dei Maccabei sembrerebbe ammettere questa possibilità (cf. 1 Mac 15,16-21).
di Stefano Tarocchi • È un fatto che il libro degli Atti utilizzi la strada di un triplice racconto per trasmettere ai suoi lettori quell’episodio chiave che cambiò definitivamente il cammino di Paolo di Tarso. Le altre narrazioni derivano dalle lettere, a cominciare dal racconto della lettera ai Galati, che usa lo stesso verbo perseguitare, che ritroviamo nelle parole di Gesù a Paolo sulla via di Damasco. Tra l’altro, Non possiamo dire con certezza che questo fatto – l’autorità del sommo sacerdote sulle comunità giudaiche al di fuori di Gerusalemme – sia storicamente provata, anche se un testo del primo libro dei Maccabei sembrerebbe ammettere questa possibilità (cf. 1 Mac 15,16-21).
Scrive san Paolo ai Galati: «Voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia si compiacque di rivelare a me suo Figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. In seguito, dopo tre anni andai a Gerusalemme per consultare Cefa, e rimasi presso di lui quindici giorni; degli apostoli non vidi nessun altro, se non Giacomo, il fratello del Signore» (Gal 1,13-19).
Si trovano accenni alla chiamata di Paolo anche in altri scritti dell’apostolo, ad esempio nella lettera ai Filippesi, quando Paolo dice di sé: «non ho certo raggiunto [la mèta], non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte. Corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù» (Fil 3,12-14).
Ma è soprattutto nella prima lettera ai Corinzi che abbiamo forse l’elemento decisivo, quando l’apostolo enumera le manifestazioni del Risorto ai discepoli: «a voi infatti ho trasmesso, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In seguito, apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre, apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli». E così conclude: «ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto [ossia qualcuno che non hai mai raggiunto lo sviluppo pieno della vita]. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio» (1 Cor 15,8-9).
Ancora una volta sembra essere la persecuzione devastante la cifra dell’agire di Paolo prima di ricevere la chiamata.
Così non è casuale che anche i tre racconti della vocazione del libro degli Atti riportino la stessa espressione di Gesù («Io sono Gesù, che tu perséguiti!») davanti alla domanda di Paolo («Chi sei, o Signore?»), che segue la prima interrogazione di Gesù («Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?»). Ecco il testo dei tre racconti in successione: «e avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signore?». Ed egli: «Io sono Gesù, che tu perséguiti!» (At 9,3-5); «mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco, verso mezzogiorno, all’improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me; caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?». Io risposi: «Chi sei, o Signore?». Mi disse: «Io sono Gesù il Nazareno, che tu perséguiti» (At 22,6-8); «); «verso mezzogiorno vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra e io udii una voce che mi diceva in lingua ebraica: «Saulo, Saulo, perché mi perséguiti? È duro per te rivoltarti contro il pungolo». E io dissi: «Chi sei, o Signore?». E il Signore rispose: «Io sono Gesù, che tu perséguiti» (At 26,13-15).
Ancor più interessante è la registrazione di un punto particolare dell’evento come è registrata, nella successione dei racconti, stavolta solo il primo e il secondo: «gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno» (At 9,7); «quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava» (At 22,9).
Dunque, facoltà sensoriali differenti vengono a colpire quanti accompagnano Paolo, ma non lui stesso, definito con esattezza nelle parole rivolte ad Anania, ancora titubante («ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome» At 9,13-14): «Va’, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’Israele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome» (At 9,15-16).
Nelle lettere pastorali si aggiunge un ulteriore tassello, dovuto alla ricostruzione della figura dell’apostolo all’interno della comunità primitiva: «Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al ministero: io che per l’innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia, perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede» (1 Tim 1,13).
Ora, il primo dei tre aggettivi usati («bestemmiatore»), oltre al consueto significato religioso, ne ha un altro per estensione, congruo con questo contesto: “diffamare, dire male, sparlare, screditare”. Il terzo aggettivo («violento») – anche questa definizione, come l’altra è tratta dal Rocci – significa “insolenza, tracotanza, sfrenata violenza, derivante dall’orgoglio di forza o di passione”. Il secondo aggettivo («persecutore») è la denominazione classica di colui che è passato dal suo ruolo opposto ai seguaci del Vangelo, tanto importante da segnalare anche ciò che accadde alla comunità dopo la morte cruenta di Stefano: «Saulo approvava la sua uccisione. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della Giudea e della Samaria» (At 8,1).
Nei testi precedenti si incontra anche il verbo «devastare»: il suo impiego nei confronti di una persona significa «oltraggiare, rovinare, maltrattare». Escluderei l’aspetto fisico, che qualche autore invece ammette, anche se negli Atti leggiamo: «Signore, essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te; e quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anche io ero presente e approvavo, e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano» (At 22,19-20). Non è che Paolo abbia voluto attaccare le persone, quanto piuttosto la loro fede: «egli intendeva scalzare la credenza della chiesa, cercando di dimostrare mediante la Scrittura che il crocifisso non poteva essere il Messia» (C. Spicq).
Comunque sia non si trattò di una conversione dell’apostolo, come siamo soliti definire la festa che ricorre il 25 gennaio, ma di una vera e propria chiamata, secondo il libro degli Atti, con tutti i caratteri di una vera e propria teofania. Questa chiamata impone comunque una missione: «Va’, perché io ti manderò lontano, alle nazioni» (At 22,21). Che è poi quello che leggiamo molto bene nella lettera ai Galati, dapprima all’inizio del cammino di Paolo fra i discepoli di Gesù («Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti (Gal 1,15-16), e quindi dopo la controversia con Cefa. Così Paolo: «visto che a me era stato affidato il Vangelo per i non circoncisi, come a Pietro quello per i circoncisi – poiché colui che aveva agito in Pietro per farne un apostolo dei circoncisi aveva agito anche in me per le genti» (Gal 2,7-8).
 Andrea Drigani dinanzi alle difficoltà e alle divergenze in cui si trova l’Unione Europa, fa memoria, a cinque anni dalla morte, di un europeista cristiano: Emilio Colombo. Dario Chiapetti dal saggio di Javier Garrido riflette su un punto della teologia francescana: la «minorità» cioè l’essere minore, che rende inseparabile la sequela di Gesù dalla chiamata ad essere fratelli. Giovanni Campanella presenta il libro-intervista di Ivan Maffeis al cardinale Angelo Bagnasco nel quale si affrontano diversi temi, tra i quali quello dell’individualismo da superarsi nella coscienza di appartenere ad una società, coscienza che rende l’uomo pienamente uomo. Mario Alexis Portella osserva sulla ripresa della vita religiosa in Cina, dove accanto al buddismo, al confucianesimo e al taoismo, emerge un ruolo significativo del cristianesimo, che il maoismo non ha potuto distruggere. Carlo Parenti riporta alcuni studi sullo stato della ricchezza del mondo che non si diffonde tra le genti ma che si ristringe nelle mani di pochi individui. Francesco Romano in margine alla recente Istruzione della Congregazione della Cause dei Santi su «Le Reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione» ne rammenta il loro valore storico e spirituale, nell’osservanza delle regole canoniche. Antonio Lovascio con il volume di Giovanni Momigli svolge alcune considerazioni sull’immigrazione, da non confondersi con l’invasione, anche alla luce del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata del Rifugiato e del Migrante. Francesco Vermigli nel cinquantenario della morte di Romano Guardini inquadra la sua opera in particolare nella riflessione teologica sulla liturgia, che dovrebbe corrispondere con l’essenza dell’uomo e con la priorità dell’azione di Dio nella storia. Carlo Nardi propone, per illustrare la dottrina del Purgatorio, l’immagine platonica dell’abbaglio, un disagio per eccesso di luce, ma che guarisce ed educa. Alessandro Clemenzia dalla Costituzione Apostolica «Veritatis Gaudium» fa emergere l’indicazione di Papa Francesco affinchè gli studi ecclesiastici si sappiano sintonizzare con il cuore dell’uomo che cerca costantemente l’incontro con la Verità. Stefano Tarocchi richiama l’attenzione sul mistero della chiamata dell’apostolo Paolo, narrata diverse volte negli scritti del Nuovo Testamento. Gianni Cioli attraverso lo studio di Chiara Frugoni sugli aspetti storici, teologici ed iconografici della Cappella degli Scrovegni, ricorda come quest’ultima contribuisca ad una proficua comprensione delle virtù. Leonardo Salutati analizza la «flat tax» rilevandone la sua iniquità, secondo i principi della morale sociale, nonché la sua inefficacia riguardo alle entrate tributarie e all’evasione fiscale. Stefano Liccioli nella figura della venerabile Madeleine Delbrêl (1904-1993) mostra una cristiana che ha saputo coniugare la dimensione mistica con l’impegno attivo a favore del prossimo.
Andrea Drigani dinanzi alle difficoltà e alle divergenze in cui si trova l’Unione Europa, fa memoria, a cinque anni dalla morte, di un europeista cristiano: Emilio Colombo. Dario Chiapetti dal saggio di Javier Garrido riflette su un punto della teologia francescana: la «minorità» cioè l’essere minore, che rende inseparabile la sequela di Gesù dalla chiamata ad essere fratelli. Giovanni Campanella presenta il libro-intervista di Ivan Maffeis al cardinale Angelo Bagnasco nel quale si affrontano diversi temi, tra i quali quello dell’individualismo da superarsi nella coscienza di appartenere ad una società, coscienza che rende l’uomo pienamente uomo. Mario Alexis Portella osserva sulla ripresa della vita religiosa in Cina, dove accanto al buddismo, al confucianesimo e al taoismo, emerge un ruolo significativo del cristianesimo, che il maoismo non ha potuto distruggere. Carlo Parenti riporta alcuni studi sullo stato della ricchezza del mondo che non si diffonde tra le genti ma che si ristringe nelle mani di pochi individui. Francesco Romano in margine alla recente Istruzione della Congregazione della Cause dei Santi su «Le Reliquie nella Chiesa: autenticità e conservazione» ne rammenta il loro valore storico e spirituale, nell’osservanza delle regole canoniche. Antonio Lovascio con il volume di Giovanni Momigli svolge alcune considerazioni sull’immigrazione, da non confondersi con l’invasione, anche alla luce del Messaggio di Papa Francesco per la Giornata del Rifugiato e del Migrante. Francesco Vermigli nel cinquantenario della morte di Romano Guardini inquadra la sua opera in particolare nella riflessione teologica sulla liturgia, che dovrebbe corrispondere con l’essenza dell’uomo e con la priorità dell’azione di Dio nella storia. Carlo Nardi propone, per illustrare la dottrina del Purgatorio, l’immagine platonica dell’abbaglio, un disagio per eccesso di luce, ma che guarisce ed educa. Alessandro Clemenzia dalla Costituzione Apostolica «Veritatis Gaudium» fa emergere l’indicazione di Papa Francesco affinchè gli studi ecclesiastici si sappiano sintonizzare con il cuore dell’uomo che cerca costantemente l’incontro con la Verità. Stefano Tarocchi richiama l’attenzione sul mistero della chiamata dell’apostolo Paolo, narrata diverse volte negli scritti del Nuovo Testamento. Gianni Cioli attraverso lo studio di Chiara Frugoni sugli aspetti storici, teologici ed iconografici della Cappella degli Scrovegni, ricorda come quest’ultima contribuisca ad una proficua comprensione delle virtù. Leonardo Salutati analizza la «flat tax» rilevandone la sua iniquità, secondo i principi della morale sociale, nonché la sua inefficacia riguardo alle entrate tributarie e all’evasione fiscale. Stefano Liccioli nella figura della venerabile Madeleine Delbrêl (1904-1993) mostra una cristiana che ha saputo coniugare la dimensione mistica con l’impegno attivo a favore del prossimo.