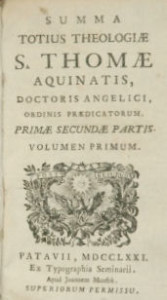Sulla recente visita del primo ministro Israeliano Netanyahu
 di Stefano Tarocchi • La recente visita fiorentina del primo ministro israeliano Benjamin (Bibi) Netanyahu, che fa seguito alla visita nelle ultime settimane del presidente del consiglio Matteo Renzi, pone all’attenzione dell’opinione pubblica un grave problema che le crisi degli ultimi dodici mesi, la complessa situazione internazionale con la questione dell’IS (o ISIS) e la situazione socio-politica del Mediterraneo, con le crisi siriane, egiziane e libiche, hanno nascosto. Si aggiunga a tutto questo l’attualissima e conseguente situazione dei rifugiati nei confini dell’Unione Europea, attraverso le fragili frontiere dell’Italia, della Grecia e dell’Ungheria (con la costruzione di decine di chilometri di barriere di filo spinato), che provoca reazioni scomposte (e talora surreali, e francamente stucchevoli) per esempio nel Regno Unito e in alcuni paesi dell’est europeo. La stessa Germania e la Francia (dopo lo spettacolo offerto alla frontiera italo-francese di Ventimiglia) stanno solo ora prendendo coscienza che il problema non può essere confinato ad un singolo paese, con le norme determinate dal trattato di Dublino.
di Stefano Tarocchi • La recente visita fiorentina del primo ministro israeliano Benjamin (Bibi) Netanyahu, che fa seguito alla visita nelle ultime settimane del presidente del consiglio Matteo Renzi, pone all’attenzione dell’opinione pubblica un grave problema che le crisi degli ultimi dodici mesi, la complessa situazione internazionale con la questione dell’IS (o ISIS) e la situazione socio-politica del Mediterraneo, con le crisi siriane, egiziane e libiche, hanno nascosto. Si aggiunga a tutto questo l’attualissima e conseguente situazione dei rifugiati nei confini dell’Unione Europea, attraverso le fragili frontiere dell’Italia, della Grecia e dell’Ungheria (con la costruzione di decine di chilometri di barriere di filo spinato), che provoca reazioni scomposte (e talora surreali, e francamente stucchevoli) per esempio nel Regno Unito e in alcuni paesi dell’est europeo. La stessa Germania e la Francia (dopo lo spettacolo offerto alla frontiera italo-francese di Ventimiglia) stanno solo ora prendendo coscienza che il problema non può essere confinato ad un singolo paese, con le norme determinate dal trattato di Dublino.
Tutto questo complesso panorama, che abbiamo descritto sommariamente, hanno oscurato il problema di una corretta informazione sulla Terra Santa, con le implicazioni che comporta, sul tessuto europeo e particolarmente italiano, capace di convogliare centinaia di migliaia di persone in quel cammino unico nell’orizzonte cristiano: il pellegrinaggio nelle terre bibliche e in particolare in Terra Santa.
La situazione di guerra che si è venuta a creare nell’estate del 2014, con i lanci di razzi dalla Striscia di Gaza su Israele e la reazione militare conseguente, hanno provocato in particolare nell’opinione pubblica italiana una reazione di paura nell’affrontare tale percorso. La dimostrazione è la caduta verticale del numero dei pellegrini (e dei viaggiatori) italiani, che va dall’estate 2014, quando la situazione ha raggiunto il suo acme, fino al momento attuale. Quello che è sempre stato percepito come un luogo da evitare per paura di attentati, di violenze e di situazioni riconducibili alla guerra, è diventato per lungo tempo un luogo tabù per definizione.
Si dimentica che esistono altri teatri molto più problematici, e certamente non in grado di garantire il livello di sicurezza, garantito, piaccia o meno, anche dalla tecnologia avanzata, come lo stesso Netanyahu ha sottolineato nel suo intervento a Palazzo Vecchio. Per avere un approccio corretto a questi problemi di sicurezza basta consultare il sito del nostro Ministero degli Affari Esteri.
Ora un’informazione corretta può essere raggiunta da ciò che è reperibile sulla rete forse in misura molto più determinante di ciò che il lettore trova sui giornali di opinione o di informazione, ma viene soprattutto cercata (e non sempre ottenuta!) sul mezzo che per definizione deve fornire suoni e immagini: la televisione. Se il mezzo è l’informazione e il mediatore dell’informazione visiva, l’inviato o il corrispondente, che non ha necessariamente (purtroppo!) una conoscenza adeguata (linguistica e biblico-culturale) del mondo che va a descrivere, di fatto può limitarsi a ripetere quello che ha visto dire da altri colleghi più preparati di lui. È così decisivo quale patrimonio di immagini (se in diretta o di archivio) accompagna la notizia. Ed inevitabile è l’impatto sullo spettatore e di come questi, a sua volta, rilancia la notizia con il passaparola: il mezzo più antico di quello che oggi può essere illustrato da un semplice filmato ripreso da uno smartphone.
Un esempio illuminante vale per tutti: lo scorso anno erano a Gerusalemme studenti della nostra Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, che partecipavano al corso estivo condotto insieme ad altre facoltà teologiche italiane ed università romane presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme. Ebbene i nostri studenti riferivano una lettura ben diversa dei missili che, secondo i vari corrispondenti, sarebbero caduti sulla Città Santa. Quelli piovuti anche sul cielo di Gerusalemme anche i lanci destinati a cadere nel deserto, che il sistema antimissile Iron-Dome riteneva innocui: tutti gli altri erano distrutti in volo, anche se le foto che gli studenti della nostra facoltà inviavano, erano apparentemente di segno diverso. Ma tutti sono ritornati a casa sani e salvi, e magari intimoriti da quello che le loro famiglie e gli amici rimasti in Italia dicevano loro, basandosi sui nostri telegiornali.
Ma l’immagine era quella che era. Ad ogni modo decine e decine di pellegrinaggi, vennero (e purtroppo sono ancora) cancellati. Anche se nessun pericolo sussiste. Semmai il problema era di altra natura, squisitamente etica: i morti e le distruzioni che ogni giorno si aggiungevano a trecento chilometri di distanza.
Un problema simile fu risolto quando la Terra Santa e Gerusalemme era di fatto esclusa dagli itinerari dei pellegrinaggi (con le classiche Roma e Santiago), con la costruzione dei complessi dei Sacri Monti, ad esempio di Varallo Sesia in Piemonte e di S. Vivaldo in Toscana, di cui parla Cardini nel suo recente Le Gerusalemme d’Italia (il Mulino, Bologna 2015), che permettevano il pellegrinaggio nelle terre bibliche senza pericoli a chi ne fosse stato impedito per ragioni di salute, di età e di condizione sociale, evitando il pericolo di un viaggio così rischioso, soprattutto dopo la caduta del regno latino di Gerusalemme (1187) e quella di Costantinopoli (1453).
Oggi al posto dei Sacri Monti, l’informazione distorta invia ai parchi delle Disneyland (la citazione è sempre tratta da Cardini) senz’anima che finiscono per prevalere in questi tempi difficili.