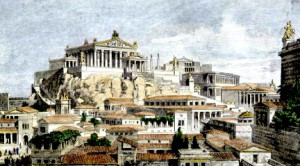di Gianni Cioli • Il Card. Dionigi Tettamanzi e il Card. Carlo Caffarra sono morti a un mese di distanza, il 5 agosto 2017 il primo e il 6 settembre il secondo. Accolgo volentieri l’invito della direzione del Mantello della Giustizia a ricordarli insieme.
di Gianni Cioli • Il Card. Dionigi Tettamanzi e il Card. Carlo Caffarra sono morti a un mese di distanza, il 5 agosto 2017 il primo e il 6 settembre il secondo. Accolgo volentieri l’invito della direzione del Mantello della Giustizia a ricordarli insieme.
Tettamanzi era nato nel 1934 a Renate, oggi in provincia di Monza, nell’arcidiocesi di Milano, Cafarra era nato nel 1938 a Samboseto, frazione di Busseto, in provincia di Parma e diocesi di Fidenza. Ad entrambi si deve riconoscere un ruolo di primo piano nell’ambito del dibattito teologico morale del postconcilio e, per certi versi, i percorsi delle loro rispettive vite possono essere interpretati come due storie simili parallele. Entrambi dopo l’ordinazione sono stati incaricati di insegnare teologia morale nelle rispettive diocesi (e mi caro rammentare che nel corso degli anni ’70 hanno insegnato anche allo Studio teologico fiorentino, su invito di don Enrico Chiavacci, succedendosi nella docenza di teologia morale familiare). Entrambi si sono segnalati per l’interesse verso tematiche morali relative al matrimonio, alla sessualità, alla bioetica, manifestando forte lealtà e sostegno al magistero pontificio, prima di Paolo VI e poi di Giovanni Paolo II, e collaborando con tutta probabilità anche alla stesura di alcuni documenti di quest’ultimo. Entrambi, dopo aver ricoperto importi incarichi a Roma nel corso degli anni ’80 (Caffarra in particolare fu chiamato a costituire e presiedere il Pontificio istituto Giovanni Paolo II per gli studi su matrimonio e famiglia), sono stati nominati vescovi (nel 1989, per l’arcidiocesi di Ancona-Osimo, Tettamanzi; nel 1995, per l’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, Caffarra). Entrambi sono divenuti infine cardinali (1998, in quanto arcivescovo di Genova, Tettamanzi che poi sarà arcivescovo di Milano dal 2002; nel 2006, in quanto arcivescovo di Bologna, Caffarra).
Non sono in grado di riassumere, né tantomeno di valutare il loro operato come pastori, e neanche penso sia possibile, nello spazio qui a disposizione, illustrare compiutamente e mettere a confronto il loro pensiero teologico.
Tuttavia, per cogliere un aspetto essenziale della loro visione morale, possono tuttavia fungere da cartina di tornasole le posizione emerse nell’ambito del dibatto sul cosiddetto compromesso etico, un tema che ho avuto modo di studiare in modo dettagliatamente.
Il concetto di compromesso etico, sviluppatosi nell’ambito della teologia luterana soprattutto negli anni ’50 del secolo scorso attraverso l’opera di Helmut Thielicke, ha richiamato l’attenzione della teologia morale cattolica a partire dalla conclusione del concilio Vaticano II. Fra coloro che ne hanno proposto la valorizzazione si distinguono in particolare il redentorista olandese Coenraad A.J. Van Ouwerkerk, e lo statunitense Charles E. Curran. Per questi autori il compromesso in campo morale può ricondursi all’idea che sia possibile ipotizzare una giustificazione oggettiva di comportamenti non conformi alle norme morali ereditate dalla tradizione, data la strutturale limitatezza umana prima del compimento escatologico.
All’indomani dell’enciclica Humanae vitae (1968), sotto la pressione ingenerata dalla necessità di affrontare pastoralmente il problema della praticabilità delle direttive ecclesiastiche sul controllo delle nascite, furono elaborate soluzioni non prive di spessore teoretico e affini alle riflessioni sul compromesso, sebbene non vi facessero esplicito riferimento. Senza mettere in discussione la validità della norma si prospettava la sostenibilità di decisioni divergenti, a motivo sia della concupiscenza quale limite alla libertà, sia della conflittualità, talora soggettivamente insostenibile, dei beni in gioco nella concretezza del vissuto. Ulteriori apporti alla comprensione e valorizzazione del compromesso etico nel contesto cattolico sono emersi negli anni ’70 e ’80 con gli di Klaus Demmer e di Helmut Weber.
Tuttavia, nel dibattito postconciliare, tale utilizzo, esplicito o implicito, del concetto di compromesso in ambito teologico morale ha sollevato varie critiche.
Tra le altre quella del gesuita Josef Fuchs, che ha ritenuto di poter ravvisare nelle teorizzazioni che vi facevano riferimento il soggiacere di una inadeguata teoria della norma. Dato che la morale normativa mira a fornire indicazioni per l’agire moralmente corretto, secondo Fuchs è necessario domandarsi se le norme operative che tutelano valori premorali abbiano sempre effettivamente l’ampiezza di validità che pretendono. In altre parole, non si dovrebbe pensare a un intrinsece malum, ovvero alla possibilità di atti intrinsecamente cattivi, quando ci si riferisce a norme operative concrete. A tale livello la norma veramente oggettiva, vale a dire adeguata alla realtà, può essere formulata solo in relazione alla situazione dal soggetto agente.
Anche Tettamanzi («Il compromesso in campo morale: una soluzione delle situazioni di conflitto?», Rivista del clero italiano 60 [1979], 948-960), in sintonia con altri autori come Ferdinando Citterio e Marcelino Zalba, ha messo decisamante in evidenza la problematicità dell’uso del termine “compromesso”, pur rifiutando radicalmente le posizioni espresse da Fuchs e da altri autori che ne condividono la sua linea. Anch’egli riconosce che nel caso di situazioni conflittuali, il problema reale è quello di definire nel modo più preciso la norma morale o dovere, ma in nome della densità dell’oggetto dell’azione come elemento primario della moralità e da una prospettiva diametralmente opposta a quella di Fuchs, vede un limite alla possibilità di ridefinizione della norma proprio nella necessità di riconoscere l’esistenza di un intrinsece malum, ovvero di atti intrinsecamente cattivi e di correlative norme proibenti, di fronte a cui non si profilano spazi per un possibile compromesso. Negare l’intrinsece malum, scrive Tettamanzi, «significa negare la struttura propria e nativa di una certa azione, o, che fa lo stesso, significa ritenere che l’uomo possa sempre e in ogni caso, inserire in una certa azione un “significato” piuttosto che un altro, o addirittura due diversi e contraddittori».
La riaffermazione dell’ordine morale oggettivo non comporta d’altra parte – riconosce Tettamanzi commentando alcune affermazioni della Familiaris consortio in materia di procreazione responsabile – la negazione delle situa-zioni personali difficili. Presupponendo che le difficoltà sono da risolversi secondo verità l’autore, sulla scorta dell’Esortazione apostolica, ribadisce però che non si deve confondere fra “gradualità della legge” e “legge della gradualità”.
Su questa linea si può collocare anche la riflessione di Caffarra il quale, riflettendo sulla peculiarità del ruolo della coscienza nell’agire morale, riconosce la possibilità di scelte non colpevoli soggettivamente o non gravemente colpevoli, pur essendo oggettivamente contro il valore, ma sottolinea tuttavia che si deve evitare un generalizzato giustificare le violazioni del valore, «in quanto questa generalizzazione sposta sostanzialmente il discorso che riguarda unicamente la mediazione operata dal singolo mediante il giudizio della propria coscienza». Generalizzare, afferma Caffarra, «è teologicamente scorretto, in quanto sarebbe ancora confondere il discorso sulla imputabilità con il discorso sulla moralità di un atto e quindi» – in rapporto alla dottrina della Humanae vitae – «pastoralmente dannoso perché la generalizzazione suonerebbe come un venir meno della testimonianza al valore della procreazione responsabile». («Alcune tesi teologiche in tema di “Procreazione responsabile”», in S. Cipriani (ed.), Evangelizzazione e matrimonio, Napoli 1975, 147). Si comprende perciò come in questa linea risulti problematica una teorizzazione del compromesso.
Certo, analoghi presupposti teoretici non sempre hanno portato a conclusioni del tutto sovrapponibili, soprattutto nella prospettiva delle soluzioni pastorali. È noto, se consideriamo i fatti più recenti, il differente genere di accoglienza che i due cardinali hanno palesato nei confronti dell’esortazione Amoris laetitia di papa Francesco. Un confronto approfondito fra le loro linee di pensiero è forse, per il momento, prematuro, ma certo, non ostante parallelismi e analogie profonde nelle loro vite e nei loro insegnamenti, si può dire che entrambi sono stati personalità notevoli ma molto differenti, sia come teologi che come pastori.
 Andrea Drigani con il ricordo di un dibattito all’Assemblea Costituente italiana nel 1947 riflette sull’uso del nome di Dio nei testi legislativi statali. Gianni Cioli presenta le vite parallele di due cardinali moralisti: Dionigi Tettamanzi e Carlo Caffarra, morti a un mese di distanza l’uno dall’altro. Giovanni Campanella ripropone, con il libro di Salvatore Muscolino, il rapporto tra il liberalismo (nelle sue variegate espressioni) e il pensiero sociale cristiano. Dario Chiapetti recensisce una recente pubblicazione che contiene il dibattito tra i filosofi Gustavo Bontadini ed Emanuele Severino sulla questione dell’essere e dell’apparire. Antonio Lovascio affronta la questione dei flussi migratori in Italia che secondo le affermazioni di Francesco e della CEI deve essere all’insegna di una accoglienza coraggiosa e prudente. Carlo Parenti ripercorre il viaggio del cardinale Pietro Parolin in Russia che fa venire in mente la lungimiranza di Giorgio La Pira che nel 1959 si recò a Mosca. Francesco Vermigli muovendo da una disposizione normativa di Papa Francesco rileva che la traduzione dei libri liturgici dal latino alle lingue nazionali deve essere sempre in profonda sintonia con la teologia ed il Magistero Ecclesiastico. Elia Carrai annota sulla scarsa volontà dell’uomo contemporaneo di porsi dei grandi interrogativi, che vanno invece favoriti, da qui l’azione della Chiesa di fornire delle risposte adeguate. Mario Alexis Portella illustra la figura del 7° Presidente Usa, Andrew Jackson (1767-1845) che come cristiano lottò per un sistema politico che ha preso il none di «Democrazia Jacksoniana». Leonardo Salutati in margine ad un incontro alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, in occasione della Giornata mondiale per il creato, rammenta che l’uomo non è il padrone della terra, bensì l’ospite sulla terra che appartiene a Dio. Giovanni Pallanti indica una risposta alle difficoltà odierne dei parroci in un romanzo di Jean Mercier e in volumetto dell’arcivescovo Mario Delpini. Francesco Romano nel 60° anniversario dell’inizio della storia dell’Unione Europea osserva che, nonostante le difficoltà ed i travagli, il cammino dell’integrazione europea, così come la pensarono i padri fondatori, non ha alternative. Alessandro Clemenzia prende spunto dal discorso di Papa Francesco ai vescovi colombiani per alcune considerazioni sulla «sacramentalità», in riferimento ai ministri sacri che sono chiamati ad essere sacramento vivente di quella libertà che non ha paura di uscire da se stessa. Carlo Nardi interpreta lo strano graffito di Alessameno, databile tra il terzo e il quarto secolo, come il modo con cui i cristiani apprezzavano quello che il mondo pagano, invece, disprezzava. Stefano Liccioli riguardo agli articoli ed ai libri che trattano di fatti delittuosi che vedono coinvolta, in qualche modo, la Chiesa, richiama l’esigenza di evitare una lettura ideologica, per coniugare libertà e verità.
Andrea Drigani con il ricordo di un dibattito all’Assemblea Costituente italiana nel 1947 riflette sull’uso del nome di Dio nei testi legislativi statali. Gianni Cioli presenta le vite parallele di due cardinali moralisti: Dionigi Tettamanzi e Carlo Caffarra, morti a un mese di distanza l’uno dall’altro. Giovanni Campanella ripropone, con il libro di Salvatore Muscolino, il rapporto tra il liberalismo (nelle sue variegate espressioni) e il pensiero sociale cristiano. Dario Chiapetti recensisce una recente pubblicazione che contiene il dibattito tra i filosofi Gustavo Bontadini ed Emanuele Severino sulla questione dell’essere e dell’apparire. Antonio Lovascio affronta la questione dei flussi migratori in Italia che secondo le affermazioni di Francesco e della CEI deve essere all’insegna di una accoglienza coraggiosa e prudente. Carlo Parenti ripercorre il viaggio del cardinale Pietro Parolin in Russia che fa venire in mente la lungimiranza di Giorgio La Pira che nel 1959 si recò a Mosca. Francesco Vermigli muovendo da una disposizione normativa di Papa Francesco rileva che la traduzione dei libri liturgici dal latino alle lingue nazionali deve essere sempre in profonda sintonia con la teologia ed il Magistero Ecclesiastico. Elia Carrai annota sulla scarsa volontà dell’uomo contemporaneo di porsi dei grandi interrogativi, che vanno invece favoriti, da qui l’azione della Chiesa di fornire delle risposte adeguate. Mario Alexis Portella illustra la figura del 7° Presidente Usa, Andrew Jackson (1767-1845) che come cristiano lottò per un sistema politico che ha preso il none di «Democrazia Jacksoniana». Leonardo Salutati in margine ad un incontro alla Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, in occasione della Giornata mondiale per il creato, rammenta che l’uomo non è il padrone della terra, bensì l’ospite sulla terra che appartiene a Dio. Giovanni Pallanti indica una risposta alle difficoltà odierne dei parroci in un romanzo di Jean Mercier e in volumetto dell’arcivescovo Mario Delpini. Francesco Romano nel 60° anniversario dell’inizio della storia dell’Unione Europea osserva che, nonostante le difficoltà ed i travagli, il cammino dell’integrazione europea, così come la pensarono i padri fondatori, non ha alternative. Alessandro Clemenzia prende spunto dal discorso di Papa Francesco ai vescovi colombiani per alcune considerazioni sulla «sacramentalità», in riferimento ai ministri sacri che sono chiamati ad essere sacramento vivente di quella libertà che non ha paura di uscire da se stessa. Carlo Nardi interpreta lo strano graffito di Alessameno, databile tra il terzo e il quarto secolo, come il modo con cui i cristiani apprezzavano quello che il mondo pagano, invece, disprezzava. Stefano Liccioli riguardo agli articoli ed ai libri che trattano di fatti delittuosi che vedono coinvolta, in qualche modo, la Chiesa, richiama l’esigenza di evitare una lettura ideologica, per coniugare libertà e verità.