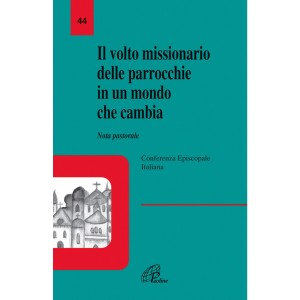di Stefano Tarocchi • All’inizio del mese di febbraio, il p. Frédéric Manns, professore emerito di esegesi neotestamentaria presso la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia di Gerusalemme dello Studium Biblicum Franciscanum, ed uno dei massimi specialisti del rapporto tra giudaismo e cristianesimo nei primi secoli, durante la sua breve permanenza a Firenze presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale – dove ha tenuto un corso alla Licenza in Teologia Biblica («Sinfonia del simbolo nuziale nel quarto Vangelo») – , ha dato una interessante conferenza sugli scavi della città di Magdala in Galilea: «Magdala. Monumenti e documenti».Qui ho inteso darne un breve compendio.
di Stefano Tarocchi • All’inizio del mese di febbraio, il p. Frédéric Manns, professore emerito di esegesi neotestamentaria presso la Facoltà di Scienze Bibliche e Archeologia di Gerusalemme dello Studium Biblicum Franciscanum, ed uno dei massimi specialisti del rapporto tra giudaismo e cristianesimo nei primi secoli, durante la sua breve permanenza a Firenze presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale – dove ha tenuto un corso alla Licenza in Teologia Biblica («Sinfonia del simbolo nuziale nel quarto Vangelo») – , ha dato una interessante conferenza sugli scavi della città di Magdala in Galilea: «Magdala. Monumenti e documenti».Qui ho inteso darne un breve compendio.
Cominciamo dalla stessa cittadina di Magdala. Fino a quando, nel 18 d.C., Erode Antipa, figlio di Erode il Grande costruisce la città di Tiberiade – il nome Tiberiade venne scelto per onorare l’imperatore romano Tiberio –, con lo scopo di farne la capitale del regno di Galilea, era l’unica città sulla sponda occidentale del Mar di Galilea e il terzo insediamento più importante della bassa Galilea dopo Sefforis e Tiberiade, a pochi chilometri a sud di Cafarnao. Magdala, era situata lungo la Via Maris, l’antica via commerciale che collegava l’Egitto alla Siria. La stessa strada da Nazareth o da Cana a Cafarnao correva proprio accanto all’ingresso settentrionale dell’attuale sito archeologico. Lo storico Giuseppe Flavio (37-100) riferisce che essa aveva quarantamila abitanti.
Gli archeologi francescani Virgilio Corbo e Stanislao Loffreda, che hanno dato un contributo insostituibile agli scavi di Cafarnao (ben diciannove campagne di scavo dal 1968 al 1986), nel 1973 iniziarono a Magdala degli scavi nella proprietà della Custodia di Terra Santa. Fu allora che ne scoprirono il porto sul lago di Tiberiade, le terme romane e parte della stessa Via Maris, la piazza centrale della città, le strade e alcuni edifici del primo secolo. In una casa fu rinvenuto anche un mosaico, raffigurante una barca a vela.
È stato, tuttavia, alla fine dello scorso decennio degli anni Duemila, quando la congregazione messicana dei Legionari di Cristo decise di creare un centro di spiritualità nella zona di Magdala, fu scoperta una delle più antiche sinagoghe di Galilea. Si pensa che la sinagoga fosse esistita a partire dal “periodo del secondo tempio” – che inizia nel 597 a.C., prosegue con l’esilio babilonese e dura fino alla distruzione del Tempio da parte dei romani, nel 70 d.C.Molti ritengono che sia stata originariamente costruita agli inizi del I secolo: si trattava di una struttura molto semplice, che venne totalmente rinnovata nell’anno 40. Essa è attualmente la più antica scavata in Galilea e una delle sette del primo secolo in tutta Israele.
All’interno della sinagoga fu trovata anche una moneta, coniata a Tiberiade nel 29 d.C. Si dimostrava così la datazione esatta, che corrisponde al tempo del ministero pubblico di Gesù: peraltro, i vangeli non vi menzionano mai la sua presenza.
Altro recente ritrovamento significativo in questo settore dell’antica città di Magdala, è una grande pietra, contenente probabilmente fra le altre la più antica raffigurazione artistica del tempio. La parte anteriore della pietra raffigura, fra altri il più antico simbolo scolpito della menorah a sette bracci del tempio, peraltro mai trovata, ed altri particolari del culto del tempio.
Dopo aver accennato ai “monumenti” veniamo adesso ai “documenti”.
Sappiamo che il Nuovo Testamento fa una menzione di un luogo chiamato Magdala. Il vangelo di Matteo così scrive: «congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magdala» (Mt 15,39). Alcuni manoscritti, però, trasmettono il nome del luogo come “Magadàn”: tali testimonianze vengono preferite nella traduzione CEI, già dall’edizione del 1974. Anche se alcuni commentatori affermano che i due nomi si riferiscono allo stesso luogo, altri respingono la sostituzione di Magdala per Magadàn.
Il racconto parallelo di Marco 8, 10 nella maggior parte dei manoscritti dà un nome di luogo ancora diverso: «Gesù salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà (Mc 8,10)». Esistono comunque codici del vangelo di Marco, leggono sia Magdala che Magadàn: ciò è dovuto al fenomeno dell’assimilazione, da parte di copisti con il testo di Matteo. Esistono interpretazioni che sostengono che Dalmanutà sia una traslitterazione della parola siriaca che indicava il “porto”.
Peraltro, Magdala, nota anche con il nome greco di Tarichea, è stata segnalata come un luogo per la salatura del pesce. Anche Giuseppe Flavio si riferisce ad una ricca città galileiana, conquistata dai Romani nella guerra ebraica (66-73 d.C.) per via della sua fiorente attività di pesca. Lo storico non riferisce il suo nome ebraico.
Il Talmud, che rappresenta, accanto alla Bibbia, il testo fondamentale dell’ebraismo sul quale si basa tutta la tradizione morale e giuridica, distingue tra due Magdala: Migdal Gadara a est, sul fiume Yarmuk vicino a Gadara (nel Medioevo “Jadar”, ora Umm Qais), acquisendo così il nome di Magdala Gadar; e Migdal Nunayya(“Magdala dei pesci”) vicino a Tiberiade, localizzata sulla riva del Mar di Galilea (così il trattato Pesahim 46a).
Anche Giuseppe Flavio nella Guerra Giudaica riporta il fatto che c’erano molte navi a Magdala durante la battaglia della prima rivolta ebraica: duecentotrenta. Infatti, anche i cantieri navali erano una industria della zona.
Luca, riferendo l’attività di Gesù, menziona, all’interno del gruppo delle seguaci di Gesù, una donna di Magdala, Maria: «egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li servivano con i loro beni» (Lc 8,1-3).Maria di Magdala è elencata come la prima tra le donne che hanno accompagnato Gesù e sostenuto il suo ministero dalle proprie risorse.
Il Vangelo di Giovanni 20, 1 narra che «il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino». E continua il testo, dopo aver descritto la corsa di Pietro e del discepolo amato: «Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto» (Gv 20,11-18).
Per questo motivo, già nel III secolo, Maria Maddalena fu descritta da Ippolito di Roma come “apostola degli Apostoli”. Eppure, la sua identità reale si è persa, a partire da quando papa Gregorio Magno pronunciò un discorso nel 591, che espresse la sua convinzione che la Maria che era stata curata da sette demoni fosse la stessa persona della penitente – erroneamente identificata come una prostituta perfino dal Caravaggio –, che unse i piedi di Gesù. Nell’antichità, fra l’altro, la malattia era ritenuta come causata dalla presenza di uno spirito cattivo: Gesù la guarisce e lei lo seguì come discepola. Il tema meriterebbe un approfondimento che rimandiamo ad altre occasioni.
Così il vangelo di Luca: «una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di profumo» (Luca 7,36-50). Questa figura di donna, che non ha nome nel Vangelo, viene poi confusa con Maria di Betania, la sorella di Marta e Lazzaro, che «prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di quel profumo» (Giovanni 12,3-8). Ma tutto questo esula dai documenti in nostro possesso, che ci restituiscono il vero volto di Maria di Magdala.
 Andrea Drigani a margine dell’Incontro svoltosi in Vaticano su «La tutela dei minori nella Chiesa» riflette sullo significato del diritto penale canonico nella connessione con la legge suprema della «salus animarum». Dario Chiapetti illustra il pensiero politico del teologo ortodosso Christos Yannaras che muovendosi dalla radici del pensiero ellenico, nel confronto la filosofia occidentale contemporanea, propone alcune interessanti annotazioni teologiche. Giovanni Campanella introduce alla lettura del volume di Ezio Aceti, una serie di meditazioni sullo Spirito Santo, che con i suoi doni permette al cristiano di giungere a maturazione per essere a sua volta un dono. Alessandro Clemenzia relaziona su un convegno di vescovi svoltosi presso l’Istituto Universitario «Sophia» di Loppiano, con al centro il tema della sinodalità, per formare alla «cultura dell’incontro» e al «coraggio dell’alterità». Antonio Lovascio presenta il rapporto sulla criminalità mafiosa nel settore agroalimentare, che aggrava il problema della fame, umiliando la dignità delle persone. Francesco Romano si sofferma sulla specificità dell’ordinamento giuridico della Chiesa, fondato sulla Rivelazione Divina, con un’identità diversa da quella degli ordinamenti secolari. Stefano Tarocchi all’insegna del rapporto tra archeologia e teologia, tra monumenti e documenti, compendia una lezione del francescano Frédéric Manns sugli scavi della città di Magdala. Giovanni Pallanti ricorda il cardinale Joszef Mindszenty (1892-1975), primate d’Ungheria, dichiarato «venerabile» da Papa Francesco, eroico testimone della fedeltà e della libertà della Chiesa. Mario Alexis Portella nel dibattito sulla possibilità dell’esistenza di uno stato democratico e laico in ambito islamico, richiama l’esperienza della rivoluzione turca di Kemal Atatürk. Gianni Cioli dal saggio di Rosa Morelli propone una serie di considerazioni sulla metodologia per una lettura «teologica» delle opere d’arte. Carlo Parenti commenta il discorso di Papa Francesco alla Pontificia Accademia per la Vita sugli aspetti positivi, ma anche sui gravi rischi sull’uso dei «robot» in special modo quando si sostituiscono alla ragione umana. Francesco Vermigli prende spunto da un famoso «spiritual» reso celebre dall’interpretazione di Louis Armstrong, per indicare nel Tempo di Quaresima l’eterno cammino dell’Esodo per liberarsi, con l’aiuto di Dio, dalla schiavitù del peccato e dall’idolatria. Leonardo Salutati affronta la questione ecologica nell’ambito della Dottrina Sociale della Chiesa che da antiche premesse teologiche (San Francesco d’Assisi) ha trovato nel recente insegnamento dei Papi (da Pio XII a Francesco) un grande interesse. Carlo Nardi col commento di San Girolamo sulla Lettera a Filemone sospinge ad una lettura integrale e completa della Bibbia, anche nell’ordinaria esistenza umana. Stefano Liccioli osserva sulla missione della parrocchia, che pur non costituendo l’unica struttura ecclesiale presente nel territorio, rimane comunque essenziale, dovendosi, tuttavia, impegnare per un’azione più capillare di evangelizzazione.
Andrea Drigani a margine dell’Incontro svoltosi in Vaticano su «La tutela dei minori nella Chiesa» riflette sullo significato del diritto penale canonico nella connessione con la legge suprema della «salus animarum». Dario Chiapetti illustra il pensiero politico del teologo ortodosso Christos Yannaras che muovendosi dalla radici del pensiero ellenico, nel confronto la filosofia occidentale contemporanea, propone alcune interessanti annotazioni teologiche. Giovanni Campanella introduce alla lettura del volume di Ezio Aceti, una serie di meditazioni sullo Spirito Santo, che con i suoi doni permette al cristiano di giungere a maturazione per essere a sua volta un dono. Alessandro Clemenzia relaziona su un convegno di vescovi svoltosi presso l’Istituto Universitario «Sophia» di Loppiano, con al centro il tema della sinodalità, per formare alla «cultura dell’incontro» e al «coraggio dell’alterità». Antonio Lovascio presenta il rapporto sulla criminalità mafiosa nel settore agroalimentare, che aggrava il problema della fame, umiliando la dignità delle persone. Francesco Romano si sofferma sulla specificità dell’ordinamento giuridico della Chiesa, fondato sulla Rivelazione Divina, con un’identità diversa da quella degli ordinamenti secolari. Stefano Tarocchi all’insegna del rapporto tra archeologia e teologia, tra monumenti e documenti, compendia una lezione del francescano Frédéric Manns sugli scavi della città di Magdala. Giovanni Pallanti ricorda il cardinale Joszef Mindszenty (1892-1975), primate d’Ungheria, dichiarato «venerabile» da Papa Francesco, eroico testimone della fedeltà e della libertà della Chiesa. Mario Alexis Portella nel dibattito sulla possibilità dell’esistenza di uno stato democratico e laico in ambito islamico, richiama l’esperienza della rivoluzione turca di Kemal Atatürk. Gianni Cioli dal saggio di Rosa Morelli propone una serie di considerazioni sulla metodologia per una lettura «teologica» delle opere d’arte. Carlo Parenti commenta il discorso di Papa Francesco alla Pontificia Accademia per la Vita sugli aspetti positivi, ma anche sui gravi rischi sull’uso dei «robot» in special modo quando si sostituiscono alla ragione umana. Francesco Vermigli prende spunto da un famoso «spiritual» reso celebre dall’interpretazione di Louis Armstrong, per indicare nel Tempo di Quaresima l’eterno cammino dell’Esodo per liberarsi, con l’aiuto di Dio, dalla schiavitù del peccato e dall’idolatria. Leonardo Salutati affronta la questione ecologica nell’ambito della Dottrina Sociale della Chiesa che da antiche premesse teologiche (San Francesco d’Assisi) ha trovato nel recente insegnamento dei Papi (da Pio XII a Francesco) un grande interesse. Carlo Nardi col commento di San Girolamo sulla Lettera a Filemone sospinge ad una lettura integrale e completa della Bibbia, anche nell’ordinaria esistenza umana. Stefano Liccioli osserva sulla missione della parrocchia, che pur non costituendo l’unica struttura ecclesiale presente nel territorio, rimane comunque essenziale, dovendosi, tuttavia, impegnare per un’azione più capillare di evangelizzazione.