 di Gianni Cioli • Alla luce della teologia battesimale di Paolo VI, si comprende l’esatta portata del significato per la vita cristiana di ciò che potremmo definire conversione permanente: «Allora per noi battezzati sorge un modo di concepire la vita, che potremmo chiamare il “dopo battesimo”, che rifletta nel pensiero, nei sentimenti, nella condotta una mentalità coerente con l’avvenimento straordinario della nostra rinascita cristiana, mediante il battesimo. Cioè dovremmo verificare se la nostra concezione della vita sia conforme alla grazia conferitaci da quel sacramento rigeneratore alla fede ch’esso reclama e all’impegno morale ch’esso comporta» (i testi degli insegnamenti di Paolo VI sono disponibili online all’indirizzo).
di Gianni Cioli • Alla luce della teologia battesimale di Paolo VI, si comprende l’esatta portata del significato per la vita cristiana di ciò che potremmo definire conversione permanente: «Allora per noi battezzati sorge un modo di concepire la vita, che potremmo chiamare il “dopo battesimo”, che rifletta nel pensiero, nei sentimenti, nella condotta una mentalità coerente con l’avvenimento straordinario della nostra rinascita cristiana, mediante il battesimo. Cioè dovremmo verificare se la nostra concezione della vita sia conforme alla grazia conferitaci da quel sacramento rigeneratore alla fede ch’esso reclama e all’impegno morale ch’esso comporta» (i testi degli insegnamenti di Paolo VI sono disponibili online all’indirizzo).
La vita cristiana «è caratterizzata da uno sforzo continuo e progressivo di rinnovamento e perfezionamento». In quanto vita, essa deve essere «in un continuo ricambio, in una continua purificazione, in un continuo accrescimento». Ma come esiste una stabilità nell’essere propria di ogni vivente, così la vita cristiana trova nel suo carattere battesimale il proprio centro di unità: «Il principio aristotelico della immobilità del centro come principio della mobilità del cerchio intorno al centro, rispecchia bene la vita cristiana. Fissità e novità: sono termini che riguardano essenzialmente la vita cristiana, simultaneamente».
Il pensiero di Paolo VI sulla vita come conversione si fonda su quella che potremmo definire la sua filosofia del tempo: «Noi cristiani dobbiamo considerare questo nostro pellegrinaggio nel mondo non come una serie di momenti staccati, che non abbiano l’uno con l’altro riferimenti di solidarietà. Siamo, invece, tenuti a riguardarli come una cosa sola, quasi un nastro che ha coerenza dentro di sé. Ivi, infatti, è un continuato disegno. I mutamenti che si succedono sono collegati da un vincolo interiore, o di passaggio di grazia o dal susseguirsi di responsabilità, sì che un momento influisce sull’altro. Oggi siamo alla scelta per il domani, al mattino lo siamo per la sera, e così via. Si troverà nella preghiera la base e il collegamento che unisce a catena gli anelli delle diverse ore».
A partire da questi presupposti, il dovere fondamentale per il cristiano apparirà quello di imprimere e di mantenere all’esistenza una direzione, un orientamento ben preciso: «La conversione, quale il battesimo esige, non presenta soltanto un aspetto negativo di allontanamento e di distacco dal peccato, ma anche e soprattutto un aspetto positivo – come conferma la stessa etimologia – di orientamento e di avvicinamento a Dio e, nel nome di Dio, al prossimo».
Convertirsi significa dunque, «dirigere la propria esistenza a Dio; cercare di compiere ciò che fanno i piloti delle navi, che a un certo punto controllano se la rotta è realmente rivolta a porto, o se, al contrario, le onde della burrasca incombente non hanno fatto deviare il percorso».
Bisogna dare a se stessi, sottolinea Paolo VI, «un punto di riferimento, un polo direttivo, un senso (cioè un significato e un indirizzo) per la vita, affinché sia veramente umana, sia cristiana». È questa la «metánoia, cioè la rettifica della propria mentalità in ordine alla vera e indispensabile interpretazione della vita».
Per il cristiano si prospetta così come permanentemente necessaria una sorta di analisi religiosa del proprio spirito: «dobbiamo ripiegarci sopra noi stessi per esaminare quale sia la vera direzione principale della nostra vita, quale sia cioè il movente abituale e prevalente del nostro modo di pensare e di agire, quale sia la nostra ragione di vivere, quale lo stile morale della nostra personalità».
Occorre una pianificazione della vita operativa che parta da alcuni interrogativi fondamentali: «Che cosa io desidero di più nella mia vita? Che cosa influisce sulle mie scelte? Che cosa considero più importante? Dov’è rivolto il mio amore primario? Qual è il criterio che più influisce sulla mia coscienza? Che cosa mi preme sopra ogni altra cosa? Qual è il primo precetto del mio vivere? ».
Questo «orientamento coraggioso da imprimere nella nostra vita cristiana», comporta, come già sottolineato, una profonda dimensione ascetica: L’ascesi cristiana, secondo Papa Montini, «consiste in uno sforzo abituale della buona volontà, una tensione morale vigilante e perseverante della coscienza sopra il dominio delle proprie azioni, una attitudine normale di autogoverno, di padronanza di sé, nell’intento di unificare il complesso meccanismo psicologico dei propri istinti, delle proprie passioni, dei propri sentimenti, delle proprie reazioni interiori ed esteriori, dei propri pensieri, sotto un unico comando direttivo, l’amor di Dio e del prossimo, norma suprema e vitale della personalità cristiana».
Unificare, cercare di «comporre in un ordine logico e morale questo nostro essere complicato e per sé capace di forme diverse di azione e di comportamento» appare come dovere fondamentale. Dovere che scaturisce dalla coscienza che «noi uomini siamo esseri complessi, polivalenti, polioperanti»; dovere che è reso più drammaticamente urgente dal fatto capitale, misterioso e realissimo del peccato originale che «ha lasciato un disordine congenito nell’uomo, che porta con sé una specie di tendenza centrifuga delle sue facoltà, le quali, senza un’azione riflessa di coordinamento e senza aiuto divino, non ricompongono più il profilo ideale, cioè la santità, la perfezione, a cui l’uomo è pur chiamato».
Il discorso si ricollega a quello della la struttura pasquale dell’esistenza cristiana, che ha il suo paradigma nell’interpretazione teologica del simbolismo battesimale: «l’essenza del cristianesimo è la carità, ciascuno di noi deve affrontare le rinunzie, i sacrifici, l’abnegazione, la perseveranza che la carità esige; fino a raggiungere una certa forma di abdicazione di noi stessi, del nostro io. Bisogna morire interiormente se si vuol rinascere».
La croce, ricorda ancora Paolo VI «non solo fa parte, ma costituisce il centro del mistero d’amore, che abbiamo scelto come vero e totale programma della nostra rinnovata esistenza».
In questo orizzonte conversione significherà necessariamente «entrare in se stessi, riflettere sulla propria persona, acquisire una nozione chiara di quel che siamo, vogliamo e facciamo; e a un certo momento, – qui la fase drammatica, ma risolutiva – conterere, rompere qualche cosa di noi, spezzare questo o quell’elemento che magari c’è molto caro ed a cui siamo abituati, sì da non rinunciarvi facilmente».
La conversione «deve rettificare la concezione, la direzione, la condotta della nostra vita; deve correggere la nostra mentalità profana, sensuale, esteriorizzata, egoista; deve ricomporre e rendere operante la logica del nostro battesimo e del nostro cristianesimo».
Se è vero che il significato più autentico della conversione è in linea di principio quello positivo, di orientamento e di avvicinamento a Dio, e anche vero che, di fatto, questo significato non può realizzarsi che come distacco dal peccato, realtà che tragicamente accompagna tutta l’esistenza terrena del cristiano e che trova la sua “paradossale” conferma nella prassi della penitenza sacramentale: «Il cristiano non è per definizione un fedele? e se fedele, ahimè! non rimane può ancora pretendere o almeno sperare, d’essere riammesso allo stato di grazia? […] Ed ecco la prima, paradossale ma reale verità: nel piano della bontà di Dio la possibilità che anche i peccati d’un cristiano, i quali dopo il suo battesimo assumono una maggiore e repellente gravità, siano perdonati, esiste!».
Il concetto di conversione si coniuga così con quello di penitenza. Un’autentica analisi interiore del nostro spirito, uno studio su noi stessi dovrebbe metterci «in grado di scoprire il groviglio della nostra psicologia operativa; troveremo forse peccati, o almeno debolezze che avrebbero bisogno di penitenza o di riforma profonda».
La coscienza del peccato è una realtà «alla quale l’uomo, di solito, cerca di sottrarsi», constata il Papa, essa «suppone la fede nel rapporto che intercede fra la nostra vita e l’inviolabile e vigilante legge di Dio». Tale fede risulta oggi per molti versi in crisi ma, prescindendo da essa, l’uomo non può comprendersi realmente.
Nel momento in cui l’uomo intuisce la realtà della propria posizione di fronte a Dio e riesce a cogliersi in un atto di coraggiosa umiltà, la verità di tale atto «diventa o disperata o penitenziale; e chi la esprime pronuncia su se stesso un giudizio di condanna, ovvero ha per sé un’invocazione di misericordia: quest’ultima invocazione è la penitenza interiore». Questo significa il coraggio di «mutare pensiero, mutare idee, mutare maniera di giudicare, mutare coscienza da falsa a vera […]. Pensare bene! Sarebbe questa la migliore metánoia, la migliore conversione, la migliore penitenza».
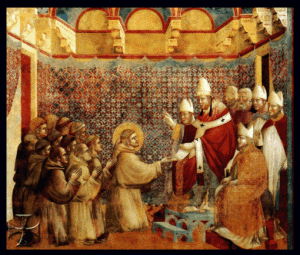 Andrea Drigani dall’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese sulle nomine vescovili, rammenta la storia degli interventi civili sulla designazione all’ufficio episcopale, la cui procedura, nella Chiesa latina, necessita, tuttavia, di ulteriori studi. Dario Chiapetti illustra da un punto di vista storico, politico e teologico le vicissitudini delle chiese ortodosse ucraine nel contrasto tra il Patriarcato di Costantinopoli e quello di Mosca. Giovanni Campanella recensisce il libro di Francis Collins che sostiene la possibilità di conciliare evoluzione e fede, poiché l’intelligenza di Dio sovrasta grandemente le nostre intelligenze. Stefano Tarocchi continuando le annotazioni bibliche su «ponti» e «pontefici» incentra la sua attenzione sulla missione di Gesù come Colui che percorre per primo quelle strade che Lui stesso ha aperto. Giovanni Pallanti si sofferma sulle origini familiari di Paolo VI e sul suo interesse per la cultura cattolico-democratica. Leonardo Salutati richiama dalla storia del cristianesimo antico i principi della morale sociale presenti nella Tradizione e le esperienze concrete, provenienti dall’esperienza monastica, di scelte di politica economica. Carlo Parenti commenta il discorso di Papa Francesco nella Cattedrale di Kaunas, durante il suo viaggio apostolico nei Paesi Baltici, che mette in guardia sui rischi della cosiddetta «società del benessere». Mario Alexis Portella svolge alcune considerazioni sui dilemmi e le difficoltà della gestione, da parte delle autorità politiche, dell’immigrazione, tenendo pure conto della crisi di valori dell’Occidente, che appare disintegrato e perciò incapace di integrare. Gianni Cioli ricorda l’insegnamento di Paolo VI sul significato della vita cristiana all’insegna di una conversione costante e continua per rendere operante il nostro Battesimo. Stefano Liccioli all’inizio di un nuovo anno scolastico e catechistico ripropone la figura e il modello di Gesù Maestro, nel senso di Maestro dei maestri e di Educatore degli educatori. Carlo Nardi con una frase di San Giovanni Crisostomo aiuta a riflettere sulla verità e sulla carità dell’Incarnazione: Dio ha assunto l’umanità. Alessandro Clemenzia presenta il volume di Chiara D’Urbano che affronta il dialogo tra l’antropologia cristiana e la psicologia per recuperare la pienezza umana e poter corrispondere alla propria vocazione. Francesco Vermigli nella memoria liturgica di Sant’Ignazio di Antiochia ne ripercorre la biografia, che costituisce una grande testimonianza di fedeltà al Vangelo con l’offerta della sua vita, non solo per la propria Chiesa particolare, ma per la Chiesa universale. Antonio Lovascio introduce alla lettura della recente intervista di Papa Francesco al quotidiano «Il Sole-24 Ore», nella quale vengono presentate, tra le altre, le questioni della crisi dalla globalizzazione, dell’economia dello scarto, dell’etica dell’impresa amica della persona.
Andrea Drigani dall’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese sulle nomine vescovili, rammenta la storia degli interventi civili sulla designazione all’ufficio episcopale, la cui procedura, nella Chiesa latina, necessita, tuttavia, di ulteriori studi. Dario Chiapetti illustra da un punto di vista storico, politico e teologico le vicissitudini delle chiese ortodosse ucraine nel contrasto tra il Patriarcato di Costantinopoli e quello di Mosca. Giovanni Campanella recensisce il libro di Francis Collins che sostiene la possibilità di conciliare evoluzione e fede, poiché l’intelligenza di Dio sovrasta grandemente le nostre intelligenze. Stefano Tarocchi continuando le annotazioni bibliche su «ponti» e «pontefici» incentra la sua attenzione sulla missione di Gesù come Colui che percorre per primo quelle strade che Lui stesso ha aperto. Giovanni Pallanti si sofferma sulle origini familiari di Paolo VI e sul suo interesse per la cultura cattolico-democratica. Leonardo Salutati richiama dalla storia del cristianesimo antico i principi della morale sociale presenti nella Tradizione e le esperienze concrete, provenienti dall’esperienza monastica, di scelte di politica economica. Carlo Parenti commenta il discorso di Papa Francesco nella Cattedrale di Kaunas, durante il suo viaggio apostolico nei Paesi Baltici, che mette in guardia sui rischi della cosiddetta «società del benessere». Mario Alexis Portella svolge alcune considerazioni sui dilemmi e le difficoltà della gestione, da parte delle autorità politiche, dell’immigrazione, tenendo pure conto della crisi di valori dell’Occidente, che appare disintegrato e perciò incapace di integrare. Gianni Cioli ricorda l’insegnamento di Paolo VI sul significato della vita cristiana all’insegna di una conversione costante e continua per rendere operante il nostro Battesimo. Stefano Liccioli all’inizio di un nuovo anno scolastico e catechistico ripropone la figura e il modello di Gesù Maestro, nel senso di Maestro dei maestri e di Educatore degli educatori. Carlo Nardi con una frase di San Giovanni Crisostomo aiuta a riflettere sulla verità e sulla carità dell’Incarnazione: Dio ha assunto l’umanità. Alessandro Clemenzia presenta il volume di Chiara D’Urbano che affronta il dialogo tra l’antropologia cristiana e la psicologia per recuperare la pienezza umana e poter corrispondere alla propria vocazione. Francesco Vermigli nella memoria liturgica di Sant’Ignazio di Antiochia ne ripercorre la biografia, che costituisce una grande testimonianza di fedeltà al Vangelo con l’offerta della sua vita, non solo per la propria Chiesa particolare, ma per la Chiesa universale. Antonio Lovascio introduce alla lettura della recente intervista di Papa Francesco al quotidiano «Il Sole-24 Ore», nella quale vengono presentate, tra le altre, le questioni della crisi dalla globalizzazione, dell’economia dello scarto, dell’etica dell’impresa amica della persona.









