 di Stefano Tarocchi • Fra i vari anniversari che il tempo della pandemia ci ha sottratto, credo vada evidenziata la nascita nell’aprile 1720 di Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, morto nel 1809. I suoi studi a Prato e a Pisa, dove si laureò in utroque iure nel 1748, lo portarono fino alla soglia della cattedra di diritto canonico nell’Università di Torino. Divenne invece direttore del Collegio di Superga.
di Stefano Tarocchi • Fra i vari anniversari che il tempo della pandemia ci ha sottratto, credo vada evidenziata la nascita nell’aprile 1720 di Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, morto nel 1809. I suoi studi a Prato e a Pisa, dove si laureò in utroque iure nel 1748, lo portarono fino alla soglia della cattedra di diritto canonico nell’Università di Torino. Divenne invece direttore del Collegio di Superga.
Nel 1757, l’anno precedente la sua morte, Benedetto XIV, già cardinale Prospero Lambertini, arcivescovo di Bologna, pubblica un decreto che annulla il divieto di leggere la Bibbia in italiano: venivano consentite la stampa e la lettura di versioni italiane della Vulgata, a condizione che esse fossero «ab apostolica sede approbatae, aut editae cum annotationibus desumptis ex sanctis Ecclesiae Patribus vel ex doctis catholicisque viris».
Il papa si sarebbe rivolto al cardinale Carlo Vittorio Amedeo Delle Lanze, prefetto della Congregazione del Concilio – antenata della Congregazione per il clero – , per sollecitare una traduzione in lingua italiana della Sacra Scrittura e, a sua volta, il cardinale pensò al Martini, e alla sua preparazione culturale, oltre che alla sua nativa conoscenza della lingua italiana, data dall’origine toscana. La stima del delle Lanze era condivisa anche dal conte Carlo Luigi Caissotti, Primo Presidente del Senato, poi Gran Cancelliere di Corte (Giovannoni).
Tra il 1769 ed il 1781 uscivano i volumi del Nuovo Testamento e nel 1781 sarebbe terminata la pubblicazione dell’Antico (1776-81). L’edizione del Martini venne stampata in varie edizioni, fino ad uscire con il testo latino a fronte, introduzioni storiche ed annotazioni tratte dalla letteratura patristica. Sarebbe stata utilizzata fino alla prima metà del Novecento. Martini per il Nuovo Testamento prese come base il testo greco, ma in alcuni passaggi preferì la lezione dalla Vulgata; per l’Antico Testamento, pur traducendo dalla Vulgata, ricorse a volte al testo ebraico con l’aiuto del rabbino di Firenze.
Terminata l’opera, in segno di riconoscenza, l’allora re di Sardegna Vittorio Amedeo III volle Martini vescovo di Bobbio. Mentre si recava a Roma per la consacrazione, intese rendere omaggio al granduca di Toscana Pietro Leopoldo. Questi fu colpito dalla sua personalità e lo volle alla guida della diocesi fiorentina, rimasta vacante per la morte dell’arcivescovo Francesco Gaetano Incontri. La stima del granduca intendeva favorire l’opera di riforma della chiesa in Toscana che questi aveva intrapresa. Lasciamo agli storici di professione l’approfondimento di questo complesso capitolo dell’episcopato di Martini, che si accompagna a quello del vescovo di Pistoia Scipione de’ Ricci, esponente del movimento del giansenismo.
Il 1781, anno della sua nomina ad arcivescovo di Firenze, vede anche il completamento della traduzione della Bibbia dal latino della Vulgata all’italiano: tutti possono così leggere la Parola di Dio. Questa versione, l’unica in quei tempi integralmente in italiano e riconosciuta come testo della nostra lingua dal vocabolario della Crusca, ebbe numerose edizioni fino a quella del 1907, pubblicata in due grossi volumi (Marconcini), e fu diffusa anche in ambito protestante, accanto alla celebre traduzione italiana del Diodati (la cui prima edizione fu pubblicata a Ginevra nel 1607, e che Martini non stimava molto…).
Nel 1771 Il Papa Pio VI approva la traduzione del Martini, anche se il suo successore Pio VII, che aveva scomunicato Napoleone Bonaparte, include anche la traduzione di Martini nell’indice dei libri proibiti (1811), che era stato riformato in precedenza da papa Lambertini.
Dopo due secoli di silenzio sulla questione, dobbiamo aspettare la metà del secolo scorso per riaprire la questione. È così che dobbiamo giungere fino a Papa Pio XIII con l’enciclica Divino Afflante Spiritu (1943), che così si esprime: «per uso e profitto dei fedeli e per facilitare l’intelligenza della divina parola, si facciano traduzioni nelle lingue volgari, e precisamente anche dai testi originali» (§1).
È vero che negli anni ‘30 del secolo scorso c’erano state due traduzioni in lingua italiana, in particolare quella dell’abate Ricciotti, ma solamente con il papa Pacelli comincia quel processo che porterà alle più importanti traduzioni nella nostra lingua, a cominciare da quella di padre Vaccari, del Pontificio Istituto Biblico (1958) e a quella, insuperata di Fulvio Nardoni (1960) – tacciata da alcuni (per invidia?) di eccessivi fiorentinismi – , che precedono le traduzioni di Garofalo (1947-1960), a più mani, come quella di Enrico Galbiati, Angelo Penna e Piero Rossano (1964), che servì come base alla traduzione della Conferenza Episcopale Italiana (uscita nel 1971 e rivista nel 1974) e la traduzione curata di Settimio Cipriani, con l’aiuto di biblisti di più confessioni (1968), la “Bibbia concordata”, che tuttavia non ebbe il successo sperato.
Ma nel frattempo era intervenuto il magistero del Vaticano II, che nella Dei Verbum così dice: «la parola di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo, la Chiesa cura con materna sollecitudine che si facciano traduzioni appropriate e corrette nelle varie lingue, di preferenza (praesertim) a partire dai testi originali dei sacri libri» (DV 22).
Come già Pio XII parlava di traduzione «anche dai testi originali», anche il Vaticano II muove dallo stesso assunto, quasi spaventato dal timore di abbandonare la Vulgata di san Girolamo. Sebbene la Vulgata resti insuperabile – di fatto completa il processo rendere la parola di Dio alla portata della lingua comunemente usata e, non fosse altro che per l’operazione culturale che ha rappresentato – non può essere deputata a prendere il posto di una lingua sacra. Peraltro, non sappiamo neppure quali testi originali avesse a disposizione.
Al tempo stesso non ci si deve accontentare del testo stabilito da Erasmo da Rotterdam (il cosiddetto textus receptus: 1516), che fu la base dalla traduzione del monaco agostiniano Martin Lutero in lingua tedesca.
Naturalmente il lavoro da compiere sulle lingue originali dovrà tenere conto della scienza della critica testuale, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, e soprattutto dei testimoni testuali greci, con tutta loro complessità.
Resta l’importanza dell’arcivescovo fiorentino Antonio Martini e del prezioso lavoro che ha compiuto, che in qualche maniera anticipa un fatto a tutt’oggi imprescindibile e tuttavia mai compreso interamente in tutta la sua portata: così scrive san Girolamo nel commento al profeta Isaia: «se secondo l’apostolo Paolo, Cristo è potenza di Dio e Sapienza di Dio, e chi non conosce le Scritture non conosce la potenza di Dio e la sua sapienza, ignorare le Scritture è ignorare Cristo».
 Andrea Drigani espone la lettera di Papa Francesco su Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787) nel 150° anniversario del conferimento del titolo di Dottore della Chiesa, ad opera di Pio IX. Carlo Nardi propone una noterella sulla questione, di cui molti hanno scritto e molto è stato scritto, sul testo del Padre nostro, inserito, nella terza edizione italiana del Messale Romano. Antonio Lovascio anche in questo tempo di pandemia rileva il significativo ruolo del volontariato, che ha rafforzato una rete di solidarietà, in aiuto alle strutture pubbliche. Alessandro Clemenzia con la Lettera Apostolica «Candor Lucis aeternae» osserva che la drammatica ed ingiusta esperienza dell’esilio, conduce Dante nelle braccia della misericordia divina, fino a diventarne, poi, un testimone. Giovanni Campanella illustra il volume, con la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, che raccoglie gli atti di due convegni di studio sul prete bolognese Luciano Gherardi (1919-1999) una figura che racchiude in se interessi pastorali, teologici, storici, liturgici di notevole valore. Francesco Romano dalla domanda di Pilato a Gesù sulla «verità» sviluppa un percorso sulle varie accezioni, incomplete, di questo termine per giungere alla Verità: Gesù Cristo. Stefano Liccioli annota che dalla crisi della famiglia e del matrimonio si è passati alla crisi demografica, per respingere le paure occorre guadare all’autentica felicità: la donazione di noi stessi. Dario Chiapetti presenta il saggio «Verba scripta», introdotto dall’arcivescovo Felice Accrocca, per favorire e divulgare San Francesco con San Francesco, cioè con i suoi scritti. Stefano Tarocchi prende spunto dai trecento anni dalla nascita di Antonio Martini (1720-1809), arcivescovo di Firenze e autore della prima traduzione italiana della Bibbia, per ripercorre la storia complessa delle versioni della Scrittura nelle lingue parlate. Leonardo Salutati ritorna a tre discorsi di Benedetto XVI sul dialogo tra fede e ragione, anche in riferimento alla vita culturale europea, riscontrando che l’impegno per la ricerca delle «cose ultime» passa attraverso la relativizzazione di quelle «penultime». Gianni Cioli da un opera pittorica del Trecento fiorentino: il Trittico delle immagini dominicane, compie una catechesi pasquale dalla quale emerge che l’dea della nostra morte va considerata attraverso la morte e la resurrezione del Signore. Carlo Parenti introduce al concetto di responsabilità sociale dell’impresa, sostenuto da una parte consistente di economisti e sociologi statunitensi, che converge con diverse indicazioni del magistero pontificio. Francesco Vermigli nella circostanza del bicentenario della morte di Napoleone, con l’aiuto dell’ode di Alessandro Manzoni, svolge alcune considerazioni sulla glorie umane, che pur avendo una loro consistenza, sono destinate a scomparire dinanzi alla gloria di Dio. Giovanni Pallanti recensisce il volume degli storici Marco Pietro e Pietro Domenico Giovannoni e del domenicano Alessandro Cortesi sul rapporto, in Giorgio La Pira, tra l’annuncio evangelico e l’impegno politico. La rubrica «Coscienza universitaria» prende le mosse dal verso dantesco: «E quindi uscimmo a riveder le stelle» per pensare intorno al rapporto tra scienza e fede.
Andrea Drigani espone la lettera di Papa Francesco su Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787) nel 150° anniversario del conferimento del titolo di Dottore della Chiesa, ad opera di Pio IX. Carlo Nardi propone una noterella sulla questione, di cui molti hanno scritto e molto è stato scritto, sul testo del Padre nostro, inserito, nella terza edizione italiana del Messale Romano. Antonio Lovascio anche in questo tempo di pandemia rileva il significativo ruolo del volontariato, che ha rafforzato una rete di solidarietà, in aiuto alle strutture pubbliche. Alessandro Clemenzia con la Lettera Apostolica «Candor Lucis aeternae» osserva che la drammatica ed ingiusta esperienza dell’esilio, conduce Dante nelle braccia della misericordia divina, fino a diventarne, poi, un testimone. Giovanni Campanella illustra il volume, con la prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, che raccoglie gli atti di due convegni di studio sul prete bolognese Luciano Gherardi (1919-1999) una figura che racchiude in se interessi pastorali, teologici, storici, liturgici di notevole valore. Francesco Romano dalla domanda di Pilato a Gesù sulla «verità» sviluppa un percorso sulle varie accezioni, incomplete, di questo termine per giungere alla Verità: Gesù Cristo. Stefano Liccioli annota che dalla crisi della famiglia e del matrimonio si è passati alla crisi demografica, per respingere le paure occorre guadare all’autentica felicità: la donazione di noi stessi. Dario Chiapetti presenta il saggio «Verba scripta», introdotto dall’arcivescovo Felice Accrocca, per favorire e divulgare San Francesco con San Francesco, cioè con i suoi scritti. Stefano Tarocchi prende spunto dai trecento anni dalla nascita di Antonio Martini (1720-1809), arcivescovo di Firenze e autore della prima traduzione italiana della Bibbia, per ripercorre la storia complessa delle versioni della Scrittura nelle lingue parlate. Leonardo Salutati ritorna a tre discorsi di Benedetto XVI sul dialogo tra fede e ragione, anche in riferimento alla vita culturale europea, riscontrando che l’impegno per la ricerca delle «cose ultime» passa attraverso la relativizzazione di quelle «penultime». Gianni Cioli da un opera pittorica del Trecento fiorentino: il Trittico delle immagini dominicane, compie una catechesi pasquale dalla quale emerge che l’dea della nostra morte va considerata attraverso la morte e la resurrezione del Signore. Carlo Parenti introduce al concetto di responsabilità sociale dell’impresa, sostenuto da una parte consistente di economisti e sociologi statunitensi, che converge con diverse indicazioni del magistero pontificio. Francesco Vermigli nella circostanza del bicentenario della morte di Napoleone, con l’aiuto dell’ode di Alessandro Manzoni, svolge alcune considerazioni sulla glorie umane, che pur avendo una loro consistenza, sono destinate a scomparire dinanzi alla gloria di Dio. Giovanni Pallanti recensisce il volume degli storici Marco Pietro e Pietro Domenico Giovannoni e del domenicano Alessandro Cortesi sul rapporto, in Giorgio La Pira, tra l’annuncio evangelico e l’impegno politico. La rubrica «Coscienza universitaria» prende le mosse dal verso dantesco: «E quindi uscimmo a riveder le stelle» per pensare intorno al rapporto tra scienza e fede.

 di Stefano Tarocchi • Fra i vari anniversari che il tempo della pandemia ci ha sottratto, credo vada evidenziata la nascita nell’aprile 1720 di Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, morto nel 1809. I suoi studi a Prato e a Pisa, dove si laureò in utroque iure nel 1748, lo portarono fino alla soglia della cattedra di diritto canonico nell’Università di Torino. Divenne invece direttore del Collegio di Superga.
di Stefano Tarocchi • Fra i vari anniversari che il tempo della pandemia ci ha sottratto, credo vada evidenziata la nascita nell’aprile 1720 di Antonio Martini, arcivescovo di Firenze, morto nel 1809. I suoi studi a Prato e a Pisa, dove si laureò in utroque iure nel 1748, lo portarono fino alla soglia della cattedra di diritto canonico nell’Università di Torino. Divenne invece direttore del Collegio di Superga.
 di Antonio Lovascio · Meritano di salire sul podio della riconoscenza pubblica, subito dopo le centinaia di migliaia di medici ed infermieri che da più di15 mesi sono in trincea negli ospedali e nelle terapie intensive per salvare vite umane dal Covid, sacrificando o comunque mettendo in pericolo anche la loro. Sono quelli che Papa Francesco chiama gli “artigiani della Misericordia”, uomini e donne impegnati nel variegato mondo del volontariato (calcolati dall’Istat in oltre 7 milioni, ma forse sono molti di più) che in questa catastrofica emergenza pandemica offrono alle istituzione un supporto incalcolabile ed allo stesso tempo insostituibile. Ben visibili con le loro azioni dietro le sigle delle organizzazioni cattoliche e laiche, anche se la “macchina” delle vaccinazioni prioritarie spesso ha dimenticato gli operatori delle ambulanze. Nelle diverse condizioni del bisogno ogni giorno coniugano con i fatti, con le loro mani, con l’ascolto, con la vicinanza, con le carezze, quella solidarietà – sono parole di Bergoglio – che “ esprime concretamente l’amore di Dio non come un sentimento vago, ma come determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune, ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti”. Solidarietà con chi soffre, con i malati, i poveri e gli indifesi. Portata avanti in silenzio da chi è mosso da valori religiosi o da chi, nell’aiutare gli altri, trova anche una risposta al bisogno di socialità.
di Antonio Lovascio · Meritano di salire sul podio della riconoscenza pubblica, subito dopo le centinaia di migliaia di medici ed infermieri che da più di15 mesi sono in trincea negli ospedali e nelle terapie intensive per salvare vite umane dal Covid, sacrificando o comunque mettendo in pericolo anche la loro. Sono quelli che Papa Francesco chiama gli “artigiani della Misericordia”, uomini e donne impegnati nel variegato mondo del volontariato (calcolati dall’Istat in oltre 7 milioni, ma forse sono molti di più) che in questa catastrofica emergenza pandemica offrono alle istituzione un supporto incalcolabile ed allo stesso tempo insostituibile. Ben visibili con le loro azioni dietro le sigle delle organizzazioni cattoliche e laiche, anche se la “macchina” delle vaccinazioni prioritarie spesso ha dimenticato gli operatori delle ambulanze. Nelle diverse condizioni del bisogno ogni giorno coniugano con i fatti, con le loro mani, con l’ascolto, con la vicinanza, con le carezze, quella solidarietà – sono parole di Bergoglio – che “ esprime concretamente l’amore di Dio non come un sentimento vago, ma come determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune, ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di tutti”. Solidarietà con chi soffre, con i malati, i poveri e gli indifesi. Portata avanti in silenzio da chi è mosso da valori religiosi o da chi, nell’aiutare gli altri, trova anche una risposta al bisogno di socialità.
 di Carlo Parenti · Un mio anziano amico, già direttore generale e amministratore delegato di alcune tra le primarie compagnie di assicurazione italiane, mi ha confessato che nel corso della sua vita ha spesso ripensato a suo padre, il quale temeva che fosse troppo sensibile e quindi potesse essere fuorviato da persone poco corrette e a sua madre, che gli insegnava ad avere rispetto per chi era più anziano di lei (mi viene in mente il tema caro a Francesco sull’importanza dell’insegnamento dei nonni). Ambedue gli hanno trasmesso principi indelebili di rettitudine e di onestà. Tali insegnamenti gli sono tornati alla mente negli anni, quando ha dovuto prendere atto che ai vertici delle Società spesso arrivavano persone non adeguate né sul piano etico né su quello professionale. Esse manifestavano la costante volontà di realizzare disegni immaginati soprattutto per produrre interessi personali, comunque particolari a vantaggio solo di pochi, indipendentemente dalle ricadute sull’azienda e sui lavoratori. Oggi , quando ha raggiunto gli 83 anni, può dire che la corazza costruita su di lui da suo padre, con il suo illuminato esempio, è stata sufficiente a respingere ogni attacco, anche quelli più pericolosi. Si è convinto, alla fine, che l’integrità ha un prezzo, ma che questo prezzo, per quanto alto sia, vale sempre la pena pagarlo. E posso testimoniare che ha personalmente molto “pagato” per salvare aziende da mani rapaci di furfanti travestiti da illuminati manager. Senza arricchirsi! E subendo ingiustizie.
di Carlo Parenti · Un mio anziano amico, già direttore generale e amministratore delegato di alcune tra le primarie compagnie di assicurazione italiane, mi ha confessato che nel corso della sua vita ha spesso ripensato a suo padre, il quale temeva che fosse troppo sensibile e quindi potesse essere fuorviato da persone poco corrette e a sua madre, che gli insegnava ad avere rispetto per chi era più anziano di lei (mi viene in mente il tema caro a Francesco sull’importanza dell’insegnamento dei nonni). Ambedue gli hanno trasmesso principi indelebili di rettitudine e di onestà. Tali insegnamenti gli sono tornati alla mente negli anni, quando ha dovuto prendere atto che ai vertici delle Società spesso arrivavano persone non adeguate né sul piano etico né su quello professionale. Esse manifestavano la costante volontà di realizzare disegni immaginati soprattutto per produrre interessi personali, comunque particolari a vantaggio solo di pochi, indipendentemente dalle ricadute sull’azienda e sui lavoratori. Oggi , quando ha raggiunto gli 83 anni, può dire che la corazza costruita su di lui da suo padre, con il suo illuminato esempio, è stata sufficiente a respingere ogni attacco, anche quelli più pericolosi. Si è convinto, alla fine, che l’integrità ha un prezzo, ma che questo prezzo, per quanto alto sia, vale sempre la pena pagarlo. E posso testimoniare che ha personalmente molto “pagato” per salvare aziende da mani rapaci di furfanti travestiti da illuminati manager. Senza arricchirsi! E subendo ingiustizie.
 di Stefano Liccioli · In questi giorni il Parlamento italiano ha dato finalmente il via libera all’assegno unico e universale mensile per i figli under 21 dal valore massimo di 250 euro. Una misura attesa da molti anni e che dovrebbe favorire la genitorialità, promuovere l’occupazione ed incoraggiare la natalità, in un momento come quello presente in cui il numero di nati in Italia nel 2020 è stato ai minimi storici (404 mila). Ci sono ancora delle insidie per questa legge come la definizione dei decreti attuativi o il reperimento delle coperture che ancora non sono state stanziate tutte, ma l’approvazione prima da parte della Camera dei deputati e poi del Senato è stato un passo importante.
di Stefano Liccioli · In questi giorni il Parlamento italiano ha dato finalmente il via libera all’assegno unico e universale mensile per i figli under 21 dal valore massimo di 250 euro. Una misura attesa da molti anni e che dovrebbe favorire la genitorialità, promuovere l’occupazione ed incoraggiare la natalità, in un momento come quello presente in cui il numero di nati in Italia nel 2020 è stato ai minimi storici (404 mila). Ci sono ancora delle insidie per questa legge come la definizione dei decreti attuativi o il reperimento delle coperture che ancora non sono state stanziate tutte, ma l’approvazione prima da parte della Camera dei deputati e poi del Senato è stato un passo importante. 
 di Gianni Cioli • La pandemia ci ha costretti a guardare in faccia la morte e a prendere coscienza della fragilità umana. La Pasqua del Signore che celebriamo all’inizio di questo mese di aprile ci ricorda che la morte non è però l’ultima parola e che la fragilità, con l’esperienza dei nostri limiti, può divenire una risorsa se ci rammemora quello che i nostri deliri di onnipotenza ci fanno facilmente e troppo spesso dimenticare, ovvero che solo il Signore ci può salvare. Il vero problema non è tanto quello del rischio di dover affrontare la morte, bensì quello del rischio di non voler affrontare la vita, sprecandola nell’autoreferenzialità.
di Gianni Cioli • La pandemia ci ha costretti a guardare in faccia la morte e a prendere coscienza della fragilità umana. La Pasqua del Signore che celebriamo all’inizio di questo mese di aprile ci ricorda che la morte non è però l’ultima parola e che la fragilità, con l’esperienza dei nostri limiti, può divenire una risorsa se ci rammemora quello che i nostri deliri di onnipotenza ci fanno facilmente e troppo spesso dimenticare, ovvero che solo il Signore ci può salvare. Il vero problema non è tanto quello del rischio di dover affrontare la morte, bensì quello del rischio di non voler affrontare la vita, sprecandola nell’autoreferenzialità.
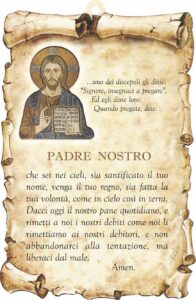
 di Francesco Vermigli · Quando troverete questo articolo pubblicato nella nostra rivista online, mancherà circa un mese a quel giorno fatidico, immortalato dalla celebre ode del Manzoni; scritta di getto in poche ore, alla notizia della morte del grande condottiero e generale. Qualche settimana ancora e saranno 200 anni da quel giorno a Sant’Elena. E – ce lo domandiamo con lo stesso don Lisander – “fu vera gloria?” Lo confessiamo: a noi, che posteri già lo siamo, ci vien meno il coraggio di rispondere a una tal domanda.
di Francesco Vermigli · Quando troverete questo articolo pubblicato nella nostra rivista online, mancherà circa un mese a quel giorno fatidico, immortalato dalla celebre ode del Manzoni; scritta di getto in poche ore, alla notizia della morte del grande condottiero e generale. Qualche settimana ancora e saranno 200 anni da quel giorno a Sant’Elena. E – ce lo domandiamo con lo stesso don Lisander – “fu vera gloria?” Lo confessiamo: a noi, che posteri già lo siamo, ci vien meno il coraggio di rispondere a una tal domanda.
 di Dario Chiapetti · Verba scripta. Un’introduzione agli scritti di frate Francesco è un testo di S. Ceccobao, P. Maranesi e C. Vaiani, con prefazione di F. Accrocca (Cittadella Editrice, Assisi 2020, 219 pp., euro 17,90), che si prefigge, come si legge nel contributo dell’arcivescovo di Benevento, di tracciare «un quadro essenziale e preciso delle questioni inerenti ai singoli scritti [del Santo d’Assisi] enucleandone la proposta spirituale» (p. 8).
di Dario Chiapetti · Verba scripta. Un’introduzione agli scritti di frate Francesco è un testo di S. Ceccobao, P. Maranesi e C. Vaiani, con prefazione di F. Accrocca (Cittadella Editrice, Assisi 2020, 219 pp., euro 17,90), che si prefigge, come si legge nel contributo dell’arcivescovo di Benevento, di tracciare «un quadro essenziale e preciso delle questioni inerenti ai singoli scritti [del Santo d’Assisi] enucleandone la proposta spirituale» (p. 8). 


 di Giovanni Pallanti · Padre Alessandro Cortesi O.P. e gli storici Marco Pietro Giovannoni e Pietro Domenico Giovannoni hanno scritto un libro molto interessante dal titolo “Giorgio La Pira, Vangelo e impegno politico”. Il libro si articola sulla biografia del professore di Diritto Romano, diventato sindaco di Firenze nel 1951, dopo avere vinto le elezioni amministrative contro il sindaco uscente Mario Fabiani, del PCI.
di Giovanni Pallanti · Padre Alessandro Cortesi O.P. e gli storici Marco Pietro Giovannoni e Pietro Domenico Giovannoni hanno scritto un libro molto interessante dal titolo “Giorgio La Pira, Vangelo e impegno politico”. Il libro si articola sulla biografia del professore di Diritto Romano, diventato sindaco di Firenze nel 1951, dopo avere vinto le elezioni amministrative contro il sindaco uscente Mario Fabiani, del PCI.