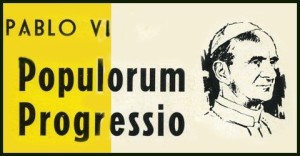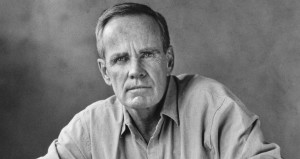di Carlo Nardi •
di Carlo Nardi •
1. A immagine di Dio
«Facciamo l’essere umano in conformità alla nostra immagine», disse fra sé e sé il buon Dio; «e lo fece in conformità alla sua immagine» (Gen 1,26). È uno dei testi più importanti e citati della Bibbia: parla di noi umani in relazione a Dio, a un Dio da cui abbiamo l’esistenza, anzi un’esistenza umana, la quale ha una “parentela” (syngéneia) con la divinità. Lo avevano detto con questa parola gli antichi Platone e discepoli, e lo ricordava l’apostolo Paolo ad Atene, nel solenne consesso dell’Areopago (At 17,28), a prima vista una specie di Accademia dei Lincei che, in realtà, poteva assumere prerogative da Corte costituzionale.
I primi cristiani, che in generale leggevano la Bibbia in greco, come avevano inteso quel “secondo (katá) l’immagine”? Lo intendevano «in conformità all’immagine di Dio», perché l’“immagine” di Dio, ossia del Padre è Cristo. Così san Paolo aveva designato Cristo: «egli è l’immagine del Dio invisibile» (Col 1,15; cf. Ebr 1,3), e che Gesù fosse l’Immagine, originaria e sostanziale, del Padre invisibile, i cristiani della grande Chiesa cattolica erano tutti d’accordo.
Teologia della salvezza della carne. Se però si fosse chiesto loro: “Perché l’uomo è a immagine di Dio o, più precisamente, è immagine dell’Immagine che è Cristo?”; o anche in che cosa sussiste l’essere a immagine di Dio, i cristiani dell’Asia sulla costa dell’Egeo e nell’entroterra, con Efeso e dintorni, ultimamente evangelizzati da san Giovanni, avrebbero risposto: “Nel corpo?”
“Ma allora Dio ha un corpo?” Si sentivano obiettare. Sì, quello del suo Figlio incarnato, fatto uomo, nel senso che Dio, quando plasmava il corpo di Adamo (Gen 2,7), lo modellava sul futuro corpo di Cristo, e pertanto il Figlio di Dio, l’“ultimo Adamo”, si sarebbe fatto uomo, anche se il primo Adamo non avesse peccato, per ricevere comunque dal Dio fattosi uomo la sua definitiva immortalità. Nella seconda metà del secondo secolo era il pensiero di sant’Ireneo di Lione tutto intento alla salvezza della carne nella futura risurrezione, al cui servizio è l’anima: nel nostro corpo siamo «a immagine di Dio», di quel Dio che si è fatto uno di noi in un vero corpo, come il nostro, perché Lui. «il Verbo si è fatto carne» (Gv 1,14).
Teologia della salvezza dell’anima. Eppure la cosiddetta teologia della carne non soddisfaceva tutti. Gli oppositori erano specialmente in Egitto, ad Alessandria nel terzo secolo: secondo loro, l’immagine di Dio era nell’anima che si esprime nel “ragionamento”, il logos, a immagine di Cristo, certo, ma di Lui in quanto Logos, inteso con la lettera maiuscola, il Verbo eterno, la seconda persona della Trinità, Pensiero e Parola del Padre. Così pensava Clemente di Alessandria (m. 215 circa) e ancor più Origene (m. 254), tutti e due intenti alla salvezza dell’anima razionale e immortale, al cui servizio è il corpo.
Compromesso o sintesi? Chi ci azzeccava? Avevano ragione tutt’e due le scuole di pensiero? È logico che tra le due linee ci fossero notevoli tensioni, che peraltro hanno fatto aguzzare la mente; e poi e soprattutto c’è del vero nell’una e nell’altra posizione. E di molto vero: in particolare l’attenzione, lo stile, il metodo con cui ci si è rapportati all’umanità in relazione a Cristo, e umanità vuol è sensi e cuore, corpo e mente, umanità che in riferimento a Cristo, vero Dio e vero uomo, comprende e trova la sua dignità (Gaudium et spes 12. cfr. 22).
Consapevoli dell’essere fatti, come ogni creatura umana, “a immagine di Dio” (Gen 1,26), i cristiani dell’antichità, anche nel commentare la Sacra Scrittura, hanno voluto raffrontarla con la loro umanità, che è la nostra umanità, la cui salvezza e pienezza è il modello di quella stessa immagine: Gesù, Verbo di Dio e nostro fratello.
La riflessione dei Padri della Chiesa è un’eco anche dell’antico detto: «Conosci te stesso», si direbbe “renditi conto di chi sei”, invito pagano che essi vedevano confermato nella parola di Dio a Mosè: «Fa’ attenzione a te stesso» (Dt 15,9 secondo i Settanta; cfr. At 20,28; 1 Tim 4,16). San Basilio commentò il detto in una limpida predica. Altri scrittori hanno contemplato l’opera di Dio nell’intero essere umano: pagine suggestive sono in Tertulliano (L’anima, La testimonianza dell’anima), in Lattanzio (La struttura dell’uomo), in Nemesio e nel più tardo Melezio Monaco nei loro trattati Sulla natura dell’uomo, e, sempre di Basilio o del fratello Gregorio, nelle Omelie sull’immagine di Dio.
Da loro riceviamo un metodo: quello di vedere, renderci conto chi siamo e come lo siamo, creature umane, e scorgere nella nostra umanità, con la ragione e la fede, il Dito di Dio che è lo Spirito Santo, creatore e santificatore, e pertanto “riconoscere la nostra dignità” (Leone Magno) e vivere di conseguenza.
Non senza un perché nella Scrittura sono così frequenti i nomi “volto”, “faccia” e i verbi “cercare, vedere il volto di Dio”, e “parlargli faccia a faccia”, “al suo cospetto”, ossia “davanti al suo volto”. E, a proposito di immagine di Dio in noi, è veramente ‘luminoso’ un Salmo della compieta domenicale e festiva nel latino della Vulgata: «si staglia su di noi la luminosità del tuo volto, o Signore (signatum est super nos lumen vultus tui, Domine), e tu hai dato gioia al mio cuore» (Sal 4,7-8 Vulgata, e così già nei Settanta).
2. A somiglianza. Anzi assimilazione
«Dio fece l’uomo a sua immagine», dice la Bibbia. Non solo: «a sua somiglianza». Stando alla versione italiana, ma anche al latino e all’originale, l’ebraico, una chiara differenza tra “immagine” e “somiglianza” non è proprio evidente (Gen 1,26).
Ma l’Antico Testamento era stato tradotto in greco. C’era una volta un re … sì, uno dei successori di Alessandro Magno in Egitto, ad Alessandria, terzo secolo avanti Cristo, mezzo greco, precisamente macedone: si chiamava Tolomeo, come gli altri della sua dinastia che ormai regnavano al posto degli antichi faraoni, detto Filadelfo. Era pagano, ma nella sua biblioteca, quella grande di Alessandria, volle che ci fossero le memorie di tutti i popoli, anche monoteisti. Faceva cultura, faceva tendenza? Di fatto, secondo un racconto leggendario, la Lettera ad Aristea, fece venire settanta o più precisamente settantadue maestri ebrei che ben sapevano il greco. Li alloggiò in settanta celle separate, e lì a tradurre, da stacanovisti.
Alla fine avrebbero – uso il condizionale –, avrebbero tradotto tutti allo stesso modo. Un qualcosa di meraviglioso, comunque, ci fu. Il mondo mediterraneo che capiva e parlava sempre più greco, finalmente poté leggere e intendere l’Antico Testamento. C’era una Bibbia in mezzo ai pagani: la riconosceranno tre secoli dopo nella predicazione degli apostoli.
Di fatto quei traduttori volevano farsi intendere dai greci. Giunti a “somiglianza”, ebraico demût, non tradussero “somiglianza”, ma, tirando non più di tanto il testo, scrissero “assimilazione”. Perché? Perché, ben esperti di letteratura greca, dovevano avere in mente, anche per le care reminiscenze di scuola, frasi importanti di Platone: la vita umana è un’assimilazione, un «assimilarsi (homoíōsis) a Dio» (Teeteto 176ab), un divenire simili a lui, per quanto ci è possibile (Repubblica X 613a).
Insomma – in base alla Bibbia greca dei Settanta – Dio ci ha fatti a sua immagine, ma perché gli si assomigli sempre più. Questo cammino è la storia della salvezza, ed è anche la vicenda, la fatica di ciascuno noi: è un qualcosa di donato, grazia, e di cercato con impegno. Soprattutto è possibile in Gesù crocifisso e risorto. E, se è vero che si assomiglia a chi si ama, assomigliare a Cristo è possibile nell’amore di Dio ricevuto e donato.
 Andrea Drigani si sofferma sul Beato Josep Mayr-Nusser, morto martire perché si rifiutò di aderire al nazismo per la fedeltà al Vangelo. Giovanni Campanella presenta il libro di Nicola Rotundo sul pensiero economico del teologo Leonard Lonergan che auspicava la partecipazione di più persone ai processi decisionali in economia. Carlo Parenti riflette su «unità» e «diversità», due termini apparentemente contraddittori, ma resi inseparabili dal pensiero cristiano. Mario Alexis Portella svolge alcune considerazioni sull’esercizio del diritto alla libertà religiosa nei paesi islamici, con particolare riferimento al Marocco e all’Egitto. Dario Chiapetti con il saggio di Ingolf Dalferth introduce al rapporto tra mondo secolare e trascendenza che fa emergere la distinzione, non più tra «sacro» e «profano», bensì tra «fede» e «incredulità». Antonio Lovascio davanti alla corruzione, che in Italia costituisce un fenomeno impressionante, richiama la necessità di favorire la trasformazione delle virtù individuali in nuovo ordine sociale, all’insegna di un’ecologia umana. Alessandro Clemenzia da un volume di Giuseppe Ruggieri prende lo spunto per annotare sulla «ripresentazione» di Cristo nella Chiesa anche in riferimento alla dimensione sinodale. Gianni Cioli leggendo il romanzo «La strada» di Cormac McCarthy, propone alcune osservazioni teologiche sulla speranza, sul rapporto tra padre e figlio e sul compromesso etico. Leonardo Salutati ripercorre la storia del diritto alla proprietà privata per concludere coll’insegnamento di Paolo VI nella «Populorum progressio». Francesco Vermigli fa memoria di Santa Caterina da Siena, patrona d’Europa, la cui figura richiama l’intero tessuto sociale europeo al senso di appartenenza ad una comunità da rifondare e da rinnovare, per essere più salda e più solidale. Stefano Liccioli prende occasione dal Messaggio del Papa per la XXXII Giornata Mondiale per la Gioventù per un’analisi della odierna situazione giovanile, contrassegnata da una frammentarietà, che rischia di non dare un senso all’esistenza. Giovanni Pallanti recensisce la recente biografia di Paolo VI scritta da Philippe Chenaux incentrata sulla formazione intellettuale e politica di Giovanni Battista Montini. Carlo Nardi commenta, con i Padri della Chiesa, l’espressione biblica dell’uomo immagine di Dio (Gen 1,26) per rammentare che la somiglianza a Cristo è possibile nell’amore di Dio ricevuto e donato. Stefano Tarocchi illustra la catechesi di Papa Francesco, per l’inizio della Quaresima, fondata sulla memoria radicata nella fede della Chiesa, sulla speranza che sostiene la fede, e il discernimento del momento.
Andrea Drigani si sofferma sul Beato Josep Mayr-Nusser, morto martire perché si rifiutò di aderire al nazismo per la fedeltà al Vangelo. Giovanni Campanella presenta il libro di Nicola Rotundo sul pensiero economico del teologo Leonard Lonergan che auspicava la partecipazione di più persone ai processi decisionali in economia. Carlo Parenti riflette su «unità» e «diversità», due termini apparentemente contraddittori, ma resi inseparabili dal pensiero cristiano. Mario Alexis Portella svolge alcune considerazioni sull’esercizio del diritto alla libertà religiosa nei paesi islamici, con particolare riferimento al Marocco e all’Egitto. Dario Chiapetti con il saggio di Ingolf Dalferth introduce al rapporto tra mondo secolare e trascendenza che fa emergere la distinzione, non più tra «sacro» e «profano», bensì tra «fede» e «incredulità». Antonio Lovascio davanti alla corruzione, che in Italia costituisce un fenomeno impressionante, richiama la necessità di favorire la trasformazione delle virtù individuali in nuovo ordine sociale, all’insegna di un’ecologia umana. Alessandro Clemenzia da un volume di Giuseppe Ruggieri prende lo spunto per annotare sulla «ripresentazione» di Cristo nella Chiesa anche in riferimento alla dimensione sinodale. Gianni Cioli leggendo il romanzo «La strada» di Cormac McCarthy, propone alcune osservazioni teologiche sulla speranza, sul rapporto tra padre e figlio e sul compromesso etico. Leonardo Salutati ripercorre la storia del diritto alla proprietà privata per concludere coll’insegnamento di Paolo VI nella «Populorum progressio». Francesco Vermigli fa memoria di Santa Caterina da Siena, patrona d’Europa, la cui figura richiama l’intero tessuto sociale europeo al senso di appartenenza ad una comunità da rifondare e da rinnovare, per essere più salda e più solidale. Stefano Liccioli prende occasione dal Messaggio del Papa per la XXXII Giornata Mondiale per la Gioventù per un’analisi della odierna situazione giovanile, contrassegnata da una frammentarietà, che rischia di non dare un senso all’esistenza. Giovanni Pallanti recensisce la recente biografia di Paolo VI scritta da Philippe Chenaux incentrata sulla formazione intellettuale e politica di Giovanni Battista Montini. Carlo Nardi commenta, con i Padri della Chiesa, l’espressione biblica dell’uomo immagine di Dio (Gen 1,26) per rammentare che la somiglianza a Cristo è possibile nell’amore di Dio ricevuto e donato. Stefano Tarocchi illustra la catechesi di Papa Francesco, per l’inizio della Quaresima, fondata sulla memoria radicata nella fede della Chiesa, sulla speranza che sostiene la fede, e il discernimento del momento.