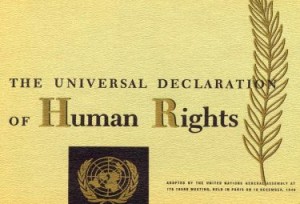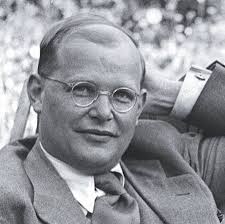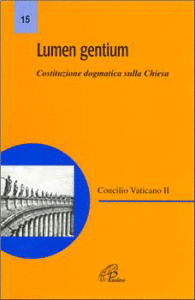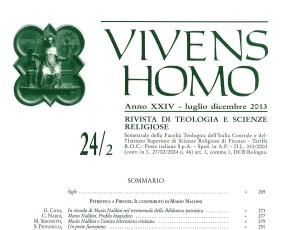In cammino verso il sinodo Panortodosso (c)
 IN ATTESA DELLA CONFERENZA PRESINODALE DEL GIUGNO 2015
IN ATTESA DELLA CONFERENZA PRESINODALE DEL GIUGNO 2015
di Basilio Petrà • Dopo le tre sessioni della Commissione preparatoria presso il Centro Patriarcale di Chambesy (Ginevra) e l’acquietarsi della polemica sulla questione delle minoranze omosessuali, della quale abbiamo parlato nei precedenti interventi, i lavori preparatori procedono senza pubblicità allo scopo di pervenire al consenso sui cinque documenti che si è deciso di selezionare per il Sinodo Panortodosso del 2016 e che saranno oggetto ulteriore discussione nella Conferenza Presinodale prevista per il giugno di quest’anno.
Nel frattempo, da varie parti si mette in luce il fatto che la storia della preparazione del Santo Sinodo è la storia della riduzione progressiva dei temi dell’agenda dei lavori. Abbiamo già visto nell’intervento precedente la riduzione operata nei confronti dei temi previsti dalla Conferenza Panortodossa Presinodale del 1976.
Ancor di più appare la riduzione nei confronti dell’agenda dei lavori prevista dalla I Conferenza Panortodossa di Rodi del 1961.
A questo confronto un po’ impietoso si sta dedicando da tempo su Amen.gr il metropolita dello Zimbabwe, Seraphim Kykkotis, del patriarcato di Alessandria, analizzando vari argomenti e vedendo il loro sviluppo e la loro eventuale decadenza all’interno dell’agenda dei lavori del futuro Sinodo Panortodosso. Ha così affrontato temi come le seconde nozze del clero, la diaspora, il digiuno, gli impedimenti matrimoniali, la pace, il movimento ecumenico, il dialogo intercristiano, la presenza dell’Ortodossia nel mondo contemporaneo. Ha anche richiamato i lavori della Commissione Propreparatoria Interortodossa, convocata dal patriarca ecumenico Fozio presso Il Monastero di Vatopedi (Monte Athos) d’accordo con le Chiese Ortodosse locali nel 1930 per preparare i temi del Presinodo Interortodosso (in vista del futuro Grande e Santo Sinodo) previsto per il 19 giugno 1932 sul Monte Athos ma poi non tenuto, riportando la lunga lista di decisioni tematiche prese: circa 17 punti. Alla fine di maggio, poi, appare e permane sempre sul sito di Amen.gr e per opera dello stesso metropolita la presentazione della lunga lista dei temi stabiliti nella I Conferenza Panortodossa di Rodi del 1961, voluta e convocata dal patriarca Athenagoras I, sulla scia peraltro dei lavori della Commissione del 1930.
L’intento che sta dietro alla presentazione di questa lista è simile a quello che abbiamo già notato nel caso di Papathanassopoulos, nel numero precedente: misurare la distanza tra i bisogni dell’Ortodossia e quello che il Sinodo del 2016 porrà a oggetto di discussione.
Questo intento è anche quello che può interessare un lettore occidentale. Perciò riteniamo utile pubblicare anche qui il catalogo dei temi stabilito da Rodi 1961.
“I. FEDE E DOGMA. A. Determinazione della nozione di dogma dal punto di vista ortodosso; B. Le fonti della divina rivelazione: a. Sacra Scrittura, 1. Ispirazione della Sacra Scrittura, 2. Valore dei Libri riconosciuti dell’Antico Testamento nella Chiesa ortodossa, 3. Edizione scientifica del testo bizantino del Nuovo Testamento; b. Sacra Tradizione (determinazione della nozione e della sua estensione); C. Testi Simbolici della Chiesa ortodossa: 1. Testi autentici nella Chiesa ortodossa, 2. Testi con valore relativo, 3. Testi con valore ausiliario, 4. Composizione e pubblicazione di un’unica Confessione di fede ortodossa; D. Nozione e Autorità della Chiesa: 1. Nozione di Chiesa; 2. Autorità della Chiesa (determinazione della sua nozione), 3. Coscienza comune della Chiesa, 4. L’infallibilità nella Chiesa che decide per mezzo della sua gerarchia nel Concilio Ecumenico.
II. CULTO DIVINO. A. Ortodossia e Bibbia: 1. Uso più esteso dell’Antico Testamento nel culto, 2. Rifrazionamento delle pericopi liturgiche in generale; B. Uniformazione del Rituale e dei testi liturgici nel culto e nella celebrazione dei sacramenti. Revisione ed edizione scientifica di essi; C. Più piena partecipazione dell’elemento laicale nella vita cultuale (e non) della Chiesa; D. Studio dei mezzi di sostegno e rafforzamento della vita liturgica nella Chiesa ortodossa e dell’arte di tradizione bizantina e in generale ortodossa nelle sue diverse espressioni (musica ecclesiastica, architettura, paramenti e arredi sacri ecc)
III. AMMINISTRAZIONE E DISCIPLINA ECCLESIASTICA. A. Codificazione dei Sacri Canoni e dei Decreti canonici, affinché abbiano a tempo debito l’approvazione del Concilio Ecumenico; B. Giustizia Ecclesiastica e Procedura penale ecclesiastica, 1. Organizzazione dei tribunali spirituali in modo se possibile uniforme nell’intera Chiesa ortodossa, 2. Formazione, se possibile, di un’identica procedura penale ecclesiastica, 3. Appello; C. Il grado episcopale: 1. Studio di un modo di elezione dei Vescovi, se possibile, più concorde con i Sacri Canoni, 2. Distinzioni amministrative ed altre nel grado episcopale: a. Patriarchi, b. Presidenti delle Chiese autocefale, c. Metropoliti, d. Arcivescovi, e. Metropoliti titolari, f. Vescovi diocesani, g. Vescovi titolari e ausiliari, Coroepiscopi; D. Vita monastica. Ricerca dei mezzi per ricondurre la vita monastica ortodossa alla sua antica bellezza e splendore attraverso la permanenza nelle tradizioni e nelle Regole monastiche e il rinnovamento della sua antica azione; E. Riadattamento dei decreti ecclesiastici sul digiuno, in accordo con le esigenze dell’epoca contemporanea; F. Formazione del sacro Clero: 1. Forma, scopo e contenuto della formazione del clero ortodosso, 2. Sottomissione della formazione del sacro clero al controllo ecclesiastico diretto, 3. Scuole ecclesiastiche per l’aggiornamento teologico (ed altro) del clero ortodosso, 4. Convegni sacerdotali di formazione ulteriore; G. Impedimenti del matrimonio. Studio della prassi attuale nelle diverse chiese riguardo ad essi e della procedura ecclesiastica seguita riguardo ad essi, tentativo di assicurare una prassi uniforme se possibile nell’intera Chiesa ortodossa riguardo ad essi; H. L’abito ecclesiastico. Modo di apparire e di vestirsi; I. La questione del calendario. Studio della questione in rapporto alla decisione sulla Pasqua del Primo Concilio Ecumenico e ricerca di un modo per ristabilire la cooperazione delle Chiese su tale questione,
IV. LE RELAZIONI RECIPROCHE TRA LE CHIESE ORTODOSSE. A. Rapporti interortodossi: a. Rapporti delle Chiese ortodosse autocefale locali tra loro e con il patriarcato ecumenico secondo i canoni e la storia, 1. Lettere ireniche, 2. Dittici, 3. Il sacro myron, 4. L’osservanza degli obblighi derivanti dai Tomi costitutivi, 5. Incontri reciproci dei Capi delle Chiese ortodosse autocefale; b. Rafforzamento delle relazioni esistenti attraverso: 1. Scambio di lettere fraterne, 2. Convocazione di Congressi Teologici, 3. Invio di Chierici e Professori, 4. Contatti tra le Scuole teologiche, 5. Scambio di professori e studenti, 6. Borse di studio, 7. Scambio di periodici, pubblicazioni e altri elementi di informazione sulla vita e l’azione della Chiesa, 8. Festeggiamento di grandi eventi ecclesiastici di significato interortodosso. B. L’autocefalia e l’autonomia nella Chiesa ortodossa: a. Proclamazione dell’autocefalia, 1. Chi fa la proclamazione, 2. Presupposti e condizioni, 3. Modo di proclamare l’autocefalia, 4. Quali sono le chiese autocefale oggi riconosciute; b. Determinazione delle condizioni di riconoscimento di una Chiesa come autonoma; c. Ortodossia e diaspora. Situazione presente e posizione canonica della diaspora ortodossa.
V. Rapporti della Chiesa ortodossa con il restante mondo cristiano. A. Studio dei modi di avvicinamento e unità tra le Chiese in una prospettiva panortodossa; B. Ortodossia e Chiese Orientali Antiche Minori: 1. Coltivazione di relazioni amichevoli verso il ristabilimento dell’unità con esse attraverso: a. scambio di visite, b. scambio di professori e studenti, c. contatti di carattere teologico; 2. Studio della storia, della fede, del culto e dell’amministrazione di queste Chiese; 3. Collaborazione con esse: a. in congressi di carattere ecumenico, b. in questioni di natura pratica; C. Ortodossia e Chiesa romanocattolica: a. Studio dei dati positivi e negativi tra le due Chiese, 1. sulla fede, 2. sull’amministrazione, 3. sull’attività ecclesiastica (in particolare la propaganda, il proselitismo, l’uniatismo); b. Coltivazione delle relazioni nello spirito della carità secondo Cristo, prendendo particolarmente in considerazione gli elementi previsti dalla Enciclica patriarcale del 1920; D. Ortodossia e Chiese e Confessioni provenienti dalla Riforma: a. Le Confessioni più lontane rispetto all’Ortodossia: 1. Luteranesimo, 2. Calvinismo, 3. Metodisti, 4. Altre Confessioni protestanti; b. Le Confessioni più vicine all’Ortodossia: 1. Gli episcopaliani in generale, 2. Chiesa anglicana; c. Studio delle possibilità di coltivazione di relazioni e ulteriore avvicinamento di essi, specialmente degli Episcopaliani e degli Anglicani, alla Chiesa ortodossa nella luce dei presupposti positivi esistenti; E. Ortodossia e Vecchiocattolicesimo. Promozione dei rapporti con i Vecchiocattolici nello spirito delle discussioni teologiche tenutesi fino ad oggi e delle loro tendenze manifestatesi verso l’unità con la Chiesa ortodossa; F. Ortodossia e movimento ecumenico: 1. La presenza e la partecipazione della Chiesa Ortodossa al movimento ecumenico nello spirito dell’Enciclica patriarcale del 1920, 2. Studio dei temi teologici e di altri temi che abbiano rapporto con i presupposti della partecipazione della Chiesa Ortodossa al movimento ecumenico, 3. Significato e contributo dell’insieme della partecipazione ortodossa nella direzione del pensiero e dell’azione ecumenica.
VI. L’ORTODOSSIA NEL MONDO. A. Studio e ricerca dei mezzi pratici, per mezzo dei quali è necessario che si rafforzi tra i popoli ortodossi la cultura cristiana ortodossa in tutte le sue manifestazioni; B. Diffusione della dottrina del Vangelo in tutto il mondo secondo la tradizione ortodossa; C. Contributo delle Chiese locali ortodosse perché prevalgano gli ideali cristiani di pace, libertà, fraternità e amore tra i popoli; D. Sviluppo dell’abitudine dei pellegrini ortodossi di andare verso i santuari presenti in ogni luogo.
VII. TEMI TEOLOGICI. A. L’economia nella Chiesa ortodossa: 1. Nozione ed espressione dei termini «acribia» e «economia» nella Chiesa ortodossa, 2. L’«economia»: a. nei sacramenti, tanto quelli celebrati entro la Chiesa quanto quelli celebrati fuori; b. nella ricezione nella Chiesa ortodossa degli eretici, degli scismatici, dei caduti (alcuni per mezzo del battesimo, altri per mezzo della crismazione, altri per mezzo del libello, altri per mezzo della preghiera); c. nel culto; B. Il riconoscimento dei santi e la determinazione di una prassi ecclesiastica ortodossa comune al riguardo; C. Ortodossia e altre religioni; D. I modi tradizionali di testimonianza dell’Ortodossia nel mondo; E. L’eutanasia e la teologia ortodossa; F. La cremazione e la teologia ortodossa.
VIII. PROBLEMI SOCIALI. A. La Chiesa ortodossa e la gioventù; B. Matrimonio e famiglia: 1. I problemi del matrimonio, 2. la procreazione, 3. l’educazione dei figli, 4. controllo delle nascite e sovrappopolazione, 5. i divorzi, 6. la procreazione artificiale; C. Enti sociali, ospizi ecc e assistenza ecclesiastica ortodossa; D. L’Ortodossia e le distinzioni razziali; E. L’Ortodossia e i problemi dei cristiani nell’ambito delle rapide trasformazioni sociali.”