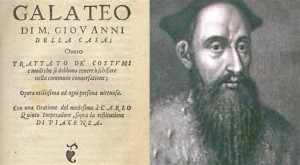di Francesco Romano • In molteplici occasioni Papa Francesco si è soffermato nelle omelie e nelle catechesi sul pericolo dell’uso distorto della ricchezza pronunciando la sua netta chiusura “a una Chiesa che vive attaccata ai soldi, che pensa ai soldi, a come guadagnare i soldi”. La Chiesa deve essere umile e fiduciosa in Dio, la povertà è la prima delle beatitudine e la vera ricchezza sono i poveri, non i soldi e il potere. La vera ricchezza è l’amore di Dio condiviso con i fratelli.
di Francesco Romano • In molteplici occasioni Papa Francesco si è soffermato nelle omelie e nelle catechesi sul pericolo dell’uso distorto della ricchezza pronunciando la sua netta chiusura “a una Chiesa che vive attaccata ai soldi, che pensa ai soldi, a come guadagnare i soldi”. La Chiesa deve essere umile e fiduciosa in Dio, la povertà è la prima delle beatitudine e la vera ricchezza sono i poveri, non i soldi e il potere. La vera ricchezza è l’amore di Dio condiviso con i fratelli.
Questa nostra riflessione vuole richiamare l’importanza per la Chiesa di possedere beni materiali solo se orientati ai fini ecclesiali. Il can. 1254 §1 afferma in modo generale: “La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, ritenere, amministrare e alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri”. La Chiesa cattolica come tale ha il diritto ai beni temporali. Si tratta di un diritto nativo che le deriva dallo stesso suo Fondatore, Gesù Cristo. Il diritto si fonda sui fini che essa deve perseguire e che le sono esclusivi e propri. Tali fini soprannaturali in sé non possono essere raggiunti senza i mezzi temporali perché la Chiesa opera nella storia, nel tempo e nello spazio. La necessità dei mezzi temporali deriva rigorosamente dalla natura e dalla missione della Chiesa. Di fatto, come afferma il can. 1254 §2, i fini che la Chiesa considera suoi ed esclusivi sono principalmente: “Ordinare il culto divino, provvedere a un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri”.
Dobbiamo chiederci come si concretizza questo diritto della Chiesa ai beni temporali per il conseguimento dei propri fini. Sappiamo che la Chiesa Cattolica in quanto tale non ha intestati i beni. Ma la Chiesa Cattolica opera attraverso la Sede Apostolica mediante l’ufficio del primato del Romano Pontefice, istituito da Gesù Cristo stesso, attraverso le Chiese particolari e attraverso tutte le altre persone giuridiche pubbliche che, per la loro stessa costituzione, per definizione agiscono a nome della Chiesa per raggiungere fini ecclesiali con speciale mandato ricevuto in vista del bene comune.
I canoni successivi precisano nell’ordinamento canonico chi ha la capacità di acquistare (can. 1255) e di possedere i beni (can. 1256) per i fini della Chiesa e quali pertanto siano i beni ecclesiastici (can. 1257 §1). Se la capacità di acquistare è riconosciuta anche alle persone giuridiche private, tuttavia la nozione di bene ecclesiastico si realizza solo nei beni delle persone giuridiche pubbliche perché solo in queste e attraverso queste agisce la Chiesa come tale. Le persone giuridiche pubbliche hanno il diritto di acquistare e possedere beni in quanto la Chiesa, erigendole e abilitandole a operare a suo nome, agisce in esse e per esse concretizzando il suo diritto ai beni temporali per il perseguimento dei suoi fini. Si dicono beni ecclesiastici, cioè della Chiesa, perché in qualche modo, ma in un senso molto profondo e vero, sono beni della Chiesa. I fini hanno pertanto un’importanza fondamentale nella considerazione dei beni della Chiesa.
I beni ecclesiastici hanno, nei fini ecclesiali, una profonda unità al punto che da questa prospettiva si potrebbe parlare di un patrimonio unico dei beni ecclesiastici. Per tanti secoli i fini sono stati così importanti che non si è neppure posto il problema del soggetto di dominio dei beni ecclesiastici, in quanto tutto veniva determinato dai fini più che dal soggetto che li possedeva. La questione del soggetto di dominio si è posta soltanto più tardi e per motivi piuttosto contingenti, cioè per proteggere in modo più sicuro i beni ecclesiastici da eventuali usurpazioni.
Si è arrivati pertanto a quella molteplicità di soggetti di dominio di cui si parla anche nel Codice vigente, particolarmente al can. 1256. La molteplicità dei soggetti di dominio non toglie però l’unità dei fini per il fatto che si tratta sempre di soggetti che hanno la loro costituzione dalla Chiesa e che agiscono in suo nome e per suo mandato. Il dominio pertanto è “sotto la Suprema Autorità del Romano Pontefice” (can. 1256) che è “il Supremo amministratore economico di tutti i beni ecclesiastici” (can. 1273). Il diritto ai beni è “a norma del diritto”, cioè è nell’ambito del diritto canonico (can. 1255).
I fini fondano il diritto ai beni e ne precisano anche i limiti. La Chiesa ha infatti il diritto ai beni e in quanto tale ha “fini propri da conseguire” (can. 1254 §1). Ma i fini ecclesiali sono soprannaturali e vanno perseguiti secondo la natura e la missione della Chiesa. Ora, la missione della Chiesa non è di ordine politico, economico o sociale, perché il suo fine è religioso (GS 42). Anche se ha bisogno di beni, essa non ripone la sua speranza nei mezzi di questo mondo (GS 76) e si serve soltanto di quei mezzi che rispondono alle esigenze del vangelo e al bene di tutti secondo le circostanze di tempo e la varietà delle condizioni umane (GS 76). In particolare, ci ammonisce ancora la Gaudium et spes, “Gli Apostoli e i loro successori come pure i loro cooperatori, quando sono inviati per annunziare agli uomini il Cristo Salvatore, nell’esercizio del loro ministero si fondano sulla potenza di Dio, il quale molte volte manifesta nella debolezza dei testimoni la potenza del vangelo. Chiunque, pertanto, si dedica al servizio della Parola di Dio, deve percorrere le vie e i mezzi propri del Vangelo, i quali differiscono per di più dai mezzi della città terrena” (GS 76).
In questo contesto possiamo comprendere le parole di Paolo VI: “La necessità dei mezzi economici e materiali, con le conseguenze che essa comporta di cercarli, di richiederli, di amministrarli, non soverchi mai il concetto dei fini a cui essi devono servire e di cui deve sentire il freno del limite, la generosità dell’impiego, la spiritualità del significato”.
Va aggiunto che i fini della Chiesa, essendo spirituali, partecipano tale spiritualità anche ai beni ecclesiastici, benché in sé materiali e temporali. I beni della Chiesa, provenendo poi tante volte dalla volontà dei fedeli che vogliono in tal modo esprimere il loro rapporto con Dio, esprimono anche un fine religioso, conferendo un valore sacrale alla loro volontà che deve essere rispettata da chi li accetta. Così i cann. 1267 §3, 1300, 1284 §2 n. 3, ribadiscono il principio di rispettare la volontà dei fedeli destinando i beni agli scopi per i quali essi li hanno dati. E’ importante sapere chi è il soggetto di dominio dei beni (subiectum inhaesionis), ma non meno importante è sapere a chi tali beni sono destinati (subiectum utilitatis).
I beni ecclesiastici, proprio perché sono beni della Chiesa e al servizio dei suoi fini, sono sotto il suo governo e retti dalle sue leggi. Il can. 1254 §1 ricorda che il diritto ai beni come pure alla loro amministrazione non deriva alla Chiesa dal potere civile, ma dallo stesso Fondatore. Perciò il dominio e l’amministrazione di essi sono regolati dal diritto canonico (cann. 1255-1256), sotto la suprema autorità del Romano Pontefice (can. 1256). Il punto di riferimento per l’amministrazione dei beni è il diritto della Chiesa, sia quello universale del Libro V del Codice, sia quello proprio (cann. 687, 635 §2).
La Chiesa vive nel tempo e ha continue relazioni con le società politiche, tra esse c’è un’osmosi continua. Le società civili possono offrire molto alla Chiesa, specialmente dal punto di vista tecnico e culturale, come anche ricevere molto presentando loro il messaggio evangelico e i valori che esso comprende. Tale osmosi è stata particolarmente forte nel campo del diritto. La Chiesa si è sviluppata in una cultura dove vigeva e imperava il diritto romano. Tale diritto, se offrì validi supporti all’organizzazione e strutturazione della Chiesa, subì anche grandi influssi benefici da parte del messaggio evangelico. Questo influsso è stato particolarmente accentuato nel campo del diritto patrimoniale. L’affermazione “Ecclesia vivit iure romano” ha trovato una speciale applicazione nel campo del diritto privato patrimoniale. Il principio era recepito anche nel Codice del 1917. Ma nello stesso Codex 1917, particolarmente al can. 1529, trovavamo il principio del rinvio al diritto civile delle nazioni. Le ragioni sono molteplici, ma è sufficiente dire che la maggioranza degli stati moderni non riconosce il diritto canonico come fonte autonoma del diritto. Se la Chiesa lo volesse urgere a ogni costo, sarebbero frequenti le liti. Si sa poi che il diritto è molto diversificato secondo le diverse nazioni. Se la Chiesa pretendesse di regolare con un proprio ordinamento universale tutto il settore dei beni temporali, sarebbe difficile, se non impossibile, un minimo di uniformità. Infine, la regolamentazione completa dei beni temporali esigerebbe una mole tale di leggi che appesantirebbero enormemente la vita ecclesiale fino a renderla quasi impossibile. La Chiesa, pertanto, nella sua prudenza ha scelto una strada sapiente e, in linea del resto con la tradizione, ha emanato una normativa molto limitata che tocca i principi e le questioni essenziali sui beni ecclesiastici.
Il Libro V è il più breve del Codice. Per il resto ha canonizzato la legislazione civile. Mediante l’istituto della canonizzazione la Chiesa da una parte salva il principio della sua competenza esclusiva per ciò che riguarda la propria vita, e dall’altra si adatta alle situazioni locali. Le leggi recepite formalmente sono leggi ecclesiastiche, così che le leggi civili obbligano i credenti all’interno della Chiesa per disposizione della stessa autorità ecclesiastica. Si tratta di vere e proprie leggi ecclesiastiche. Materialmente, invece, cioè in quanto al contenuto, sono leggi delle nazioni nelle quali la Chiesa vive. Il can. 22 ci dà il principio generale sulla canonizzazione delle leggi civili: “Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengono osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti”.
Il principio generale trova ulteriori specificazioni in tutto il codice. In particolare ricordiamo il can. 197 a proposito della prescrizione: “la prescrizione, come modo di acquisire o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita nella Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo codice”. Per la materia che ci interessa dobbiamo infine fare menzione soprattutto del can. 1290, per l’ampiezza delle applicazioni che esso comporta: “Le norme di diritto civile vigente nel territorio sui contratti sia in genere che in specie, e sui pagamenti, siano osservate per il diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino, oppure che non sia disposto diversamente dal diritto canonico, ferma restando la prescrizione del can. 1547”. Con tale canone gran parte della legislazione civile in campo patrimoniale entra nel diritto canonico.
Rientra in una misura di prudenza il can. 1284 §2 n. 2 che vuole che i titoli di proprietà dei beni ecclesiastici siano assicurati anche di fronte alla legge civile, e quella del can. 1284 §2 n. 3 che raccomanda di non arrecare danni alla Chiesa per l’inosservanza della legge civile. Il can. 1293 §2 a proposito delle alienazioni impone che “si osservino anche le altre cautele prescritte dall’autorità legittima per evitare danni alla Chiesa”. Il can. 1299 §2 raccomanda che “nelle disposizioni valevoli in caso di morte a favore della Chiesa si osservino, se possibile, le formalità del diritto civile”, ma precisa, se queste furono omesse, che gli eredi devono essere ammoniti circa il loro obbligo di adempiere la volontà del testatore”. Il can.1296 fa l’ipotesi di alienazioni invalide per la legge canonica, ma valide per la legge civile. La norma espressa dal can. 1286 riguardo alle leggi civili circa i lavori e la retribuzione è semplicemente un richiamo a un obbligo che già di per sé si impone in forza della stessa legge civile.
In questa prospettiva i beni ecclesiastici, proprio perché devono servire ai fini della Chiesa, conservano una destinazione che deve essere sempre ecclesiale. Da questo punto di vista i beni ecclesiastici hanno sempre un carattere comunionale ed entro certi limiti, a norma del diritto, devono essere anche comunicati, in ordini all’urgenza e alla priorità dei fini.
 Andrea Drigani si sofferma sui rapporti, ormai alquanto divaricati, tra il matrimonio cristiano e quello civile, di qui la necessità di ricordare il valore primario del sacramento a prescindere dal riconoscimento statale, che tuttavia non è da escludersi. Francesco Romano richiama i principi teologici e le norme canoniche sull’uso dei beni ecclesiastici, perché la loro gestione sia sempre consona ai fini spirituali che li sono propri. Gianni Cioli ancora nel contesto dell’Anno Giubilare ripropone l’insegnamento del Beato Paolo VI sulle indulgenze e sul senso della penitenza. Dario Chiapetti presenta il libro-intervista al cardinale Georges Cottier, recentemente scomparso, che contribuisce a comprendere il Mistero della Chiesa, alla luce del Vaticano II e del successivo magistero pontificio. Alessandro Clemenzia osserva che Papa Francesco, per spiegare fenomeni complessi, quali la Chiesa e certi processi sociologici, recupera come «modelli» alcune figure geometriche. Antonio Lovascio riflette sul grave fenomeno del gioco d’azzardo, dalle molte ed inquietanti connessioni, che sembra quasi impossibile regolamentare per impedire nefaste conseguenze economiche sulla vita dei giovani e delle famiglie. Francesco Vermigli da un recente volume di Linda Pocher prende spunto per una serie di riflessioni sulla differenza tra l’uomo e la donna alla luce dell’antropologia biblica, per la quale non abbiamo un corpo, ma siamo un corpo. Carlo Nardi rileva come anche la mentalità del «Galateo» sia utile per gustare e amare la liturgia. Giovanni Campanella con un saggio del gesuita Gaël Giraud ripercorre le tappe della grave e persistente crisi finanziaria mondiale, indicando alcune linee di soluzione radicate nella migliore tradizione cristiana. Stefano Liccioli indica alcuni aspetti pedagogici dell’«Amoris Laetitia» con riferimento all’approccio educativo dei genitori e alla formazione etica dei ragazzi. Leonardo Salutati annota sulla collocazione del diritto all’obiezione di coscienza nell’ambito delle libertà fondamentali dell’uomo, la cui specifica tutela non appare sufficientemente recepita nelle democrazie occidentali. Giovanni Pallanti dalla lettura di un volume del giornalista Fulvio Scaglione trae alcune considerazioni sugli ambigui rapporti commerciali ed economici tra alcuni Stati occidentali e l’Arabia Saudita che fomenta il terrorismo islamico. Stefano Tarocchi commentando una ricerca dello storico Aldo Schiavone invita a studiare la figura di Ponzio Pilato, personaggio enigmatico e mai pienamente conosciuto.
Andrea Drigani si sofferma sui rapporti, ormai alquanto divaricati, tra il matrimonio cristiano e quello civile, di qui la necessità di ricordare il valore primario del sacramento a prescindere dal riconoscimento statale, che tuttavia non è da escludersi. Francesco Romano richiama i principi teologici e le norme canoniche sull’uso dei beni ecclesiastici, perché la loro gestione sia sempre consona ai fini spirituali che li sono propri. Gianni Cioli ancora nel contesto dell’Anno Giubilare ripropone l’insegnamento del Beato Paolo VI sulle indulgenze e sul senso della penitenza. Dario Chiapetti presenta il libro-intervista al cardinale Georges Cottier, recentemente scomparso, che contribuisce a comprendere il Mistero della Chiesa, alla luce del Vaticano II e del successivo magistero pontificio. Alessandro Clemenzia osserva che Papa Francesco, per spiegare fenomeni complessi, quali la Chiesa e certi processi sociologici, recupera come «modelli» alcune figure geometriche. Antonio Lovascio riflette sul grave fenomeno del gioco d’azzardo, dalle molte ed inquietanti connessioni, che sembra quasi impossibile regolamentare per impedire nefaste conseguenze economiche sulla vita dei giovani e delle famiglie. Francesco Vermigli da un recente volume di Linda Pocher prende spunto per una serie di riflessioni sulla differenza tra l’uomo e la donna alla luce dell’antropologia biblica, per la quale non abbiamo un corpo, ma siamo un corpo. Carlo Nardi rileva come anche la mentalità del «Galateo» sia utile per gustare e amare la liturgia. Giovanni Campanella con un saggio del gesuita Gaël Giraud ripercorre le tappe della grave e persistente crisi finanziaria mondiale, indicando alcune linee di soluzione radicate nella migliore tradizione cristiana. Stefano Liccioli indica alcuni aspetti pedagogici dell’«Amoris Laetitia» con riferimento all’approccio educativo dei genitori e alla formazione etica dei ragazzi. Leonardo Salutati annota sulla collocazione del diritto all’obiezione di coscienza nell’ambito delle libertà fondamentali dell’uomo, la cui specifica tutela non appare sufficientemente recepita nelle democrazie occidentali. Giovanni Pallanti dalla lettura di un volume del giornalista Fulvio Scaglione trae alcune considerazioni sugli ambigui rapporti commerciali ed economici tra alcuni Stati occidentali e l’Arabia Saudita che fomenta il terrorismo islamico. Stefano Tarocchi commentando una ricerca dello storico Aldo Schiavone invita a studiare la figura di Ponzio Pilato, personaggio enigmatico e mai pienamente conosciuto.