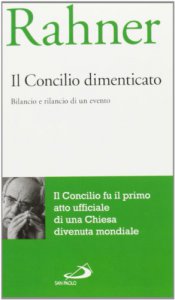Oggi più che mai responsabili del domani
 di Stefano Liccioli • Il mese scorso ho condiviso alcune riflessioni sulla relazione tra vecchie e nuove generazioni. Questa volta intendo proseguire il discorso, concentrandomi però sulle generazioni future, quelle che verranno. Come dobbiamo guardare ai nostri posteri, a quel prossimo che ancora non vediamo?
di Stefano Liccioli • Il mese scorso ho condiviso alcune riflessioni sulla relazione tra vecchie e nuove generazioni. Questa volta intendo proseguire il discorso, concentrandomi però sulle generazioni future, quelle che verranno. Come dobbiamo guardare ai nostri posteri, a quel prossimo che ancora non vediamo?
Qualche numero per pensare. Secondo uno studio commissionato dal segretario generale della Nazioni Unite (il Millennium Ecosystem Assesment del 2005), dal 2000 al 2010 il consumo di acqua è cresciuto del 10%, la domanda globale di raccolti ad uso alimentare è prevista in crescita del 70-85% tra il 2000 e il 2050, il tasso di riscaldamento degli ultimi 50 anni risulta quasi il doppio di quello per gli ultimi 100 anni. Il pericolo in agguato è che il mito di Saturno diventi realtà, il dio che divora i suoi figli rischia di essere l’immagine più appropriata per descrivere il nostro rapporto con le generazioni future: padri che mangiano il pane dei propri figli e li condannano alla morte.
Per evitare questo scenario occorre, oggi più che mai, adottare un’etica della responsabilità proporzionata alla portata del nostro sapere ed alle possibilità del nostro agire. Oggi infatti il potere umano può avere delle conseguenze a lungo termine inimmaginabili anche dallo scienziato. Il filosofo Hans Jonas a tal riguardo aveva osservato che nella nostra epoca la presenza dell’uomo nel mondo non è più un dato indiscutibile, ma deve diventare oggetto dell’obbligazione. Jonas formula così un nuovo imperativo etico:«Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana sulla Terra». Visto che la posta in gioco è così alta (la sopravvivenza dell’uomo sul Pianeta), il pensatore invita a prestare più ascolto alla profezia di sventura che non a quella di salvezza, a coltivare un senso di timore per le conseguenze delle proprie azioni, una paura che però non è qualcosa che ci distoglie dall’agire, ma vuol dire prendersi cura delle generazioni future.
Cosa fare in concreto? Intanto credo che sia necessario prendere realmente coscienza che una crescita infinita è incompatibile con un mondo finito, che le nostre produzioni e i nostri consumi non possono superare la capacità di rigenerazione della biosfera. A tal riguardo ci sono varie teorie economiche: alcune parlano di sviluppo sostenibile, altre di riduzione della crescita della popolazione, c’è chi invece come Serge Latouche che parla di decrescita felice o abbondanza frugale. Non si tratta di una crescita negativa, ma di un’ a-crescita: dobbiamo, secondo lui, rigettare il culto di una crescita economica fine a se stessa. L’obiettivo è una società in cui si vivrà meglio, consumando meglio (in maniera più razionale). Per spiegare più chiaramente la sua tesi Latouche usa una similitudine, quella con la lumaca:«La lumaca costruisce la delicata architettura del suo guscio aggiungendo una dopo l’altra delle spire sempre più larghe, poi smette bruscamente e comincia a creare delle circonvoluzioni stavolta decrescenti. Una sola spira più larga darebbe al guscio una dimensione sedici volte più grande”. La lumaca, evidentemente dimostrando maggiore saggezza degli uomini, “capisce” che quella eccessiva grandezza peggiorerebbe la qualità della sua esistenza e allora abbandona la ragione geometrica in favore di una progressione aritmetica». Non so dire se le idee di Latouche possono essere una soluzione. Certo è che nello scegliere oggi quale stile di vita adottare o quali decisioni prendere per salvaguardare il creato, non possiamo non sentirci responsabili di quel prossimo che ancora non ha volto, ma che dipende da noi.
Concludo citando un passaggio della “Populorum progressio”, una delle più importanti encicliche di quel Paolo VI che è stato recentemente proclamato beato. Anche papa Montini richiamò tutti a dare il proprio contributo, a non tirarsi indietro davanti alle sfide che c’interpellano:«L’ora dell’azione è già suonata: la sopravvivenza di tanti bambini innocenti, l’accesso a una condizione umana di tante famiglie sventurate, la pace del mondo, l’avvenire della civiltà sono in gioco. A tutti gli uomini e a tutti i popoli di assumersi le loro responsabilità».