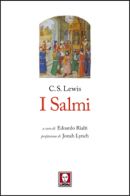Gregorio Magno e la fine del mondo antico
 di Francesco Vermigli • In un anno segnato dalla canonizzazione di due papi (Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, lo scorso 27 aprile) e dalla beatificazione di un altro (Paolo VI, il prossimo 19 ottobre) richiamare alla memoria la figura di san Gregorio Magno (papa dal 590 al 604) non sembra esser stonato. Il mese di settembre poi si apre (il giorno 3) proprio con la memoria liturgica di questo pontefice, che si staglia come personaggio grandioso nella storia della Chiesa latina e della civiltà occidentale.
di Francesco Vermigli • In un anno segnato dalla canonizzazione di due papi (Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, lo scorso 27 aprile) e dalla beatificazione di un altro (Paolo VI, il prossimo 19 ottobre) richiamare alla memoria la figura di san Gregorio Magno (papa dal 590 al 604) non sembra esser stonato. Il mese di settembre poi si apre (il giorno 3) proprio con la memoria liturgica di questo pontefice, che si staglia come personaggio grandioso nella storia della Chiesa latina e della civiltà occidentale.
Nell’epoca che vive Gregorio, convivono il sostrato romano e la generalizzata cristianizzazione di queste popolazioni di antica tradizione con un’ondata di invasioni germaniche, almeno per l’Italia, senza precedenti. Il mondo germanico, in Italia quello longobardo, poggiava su principi e su strutture sociali aliene dalla romanitas. In tutto questo, infine, il collegamento con l’Impero romano d’Oriente (che si potrebbe già appellare “bizantino”) si allenta, quasi fino a rompersi.
Gregorio è una figura singolarissima, un volto poliedrico di questo mondo scosso da tensioni di natura etnica sempre più forti, depauperato da una situazione di quasi disperante miseria, lacerato da epidemie e carestie. Egli – patrizio romano, ambasciatore pontificio a Costantinopoli, monaco – asceso alla sede di Pietro svolgerà un ruolo politico ed ecclesiale mai assunto prima da un papa, escluso forse Leone, l’altro Magno. Non solo con l’opera di ricompattamento della realtà ecclesiale testimoniato dalle sue lettere – specialmente riconducendo all’unità disciplinare e dottrinale l’episcopato occidentale – o nella promozione di un nuovo slancio evangelizzatore, in modo particolare verso le Isole Britanniche. Già! la “nuova evangelizzazione” di papa Gregorio… Essa venne a inaugurare una stagione di leggende, che colorirono di un tocco quasi fiabesco quest’epopea del Vangelo in Inghilterra: dall’incontro casuale di un gruppo di angli venduti al mercato degli schiavi di Roma, che apparvero a Gregorio non angli, piuttosto angeli; fino alla narrazione della conversione del re da parte di un solerte evangelizzatore, che colse un episodio insignificante come l’entrata furtiva e l’immediata uscita da una stanza di un castello da parte di un uccello in cerca di calore in una notte d’inverno, per trattare dell’essenza della fede cristiana.
Ma sono piuttosto i suoi scritti a render conto di una capacità di lettura della realtà a lui contemporanea fuori dal comune. Un’attenzione ai fatti e alle vicende della storia che è mossa da un criterio interpretativo certo: la storia deve essere letta alla luce dell’azione provvidente di Dio. Nei Dialogi Gregorio mostra che l’epoca sua non deve invidiare niente a quelle precedenti, ché è l’epoca dei santi, dei taumaturghi, degli uomini di Dio: qui il campione della santità è il Benedetto non della Regula, ma quello dei miracoli e delle pratiche ascetiche. Nella sua Regula pastoralis il papa invece tratteggia i contorni del retto pastore, del praedicator che conosce le proprie pecore e adatta ad esse la propria arte oratoria. Nelle omelie su Ezechiele, infine, il tono si fa profetico, la storia è nelle mani di Dio: Egli agisce per mezzo dei predicatori, coloro che hanno il compito di annunziare il Vangelo.
Lo sguardo di Gregorio è costantemente rivolto al futuro. Sente di poter guidare la storia, non – o almeno non solo – con gli strumenti di questo mondo, ma nella confidenza fermissima nella protezione di Dio. Il suo slancio missionario, allora, se riletto alla luce di ciò che egli scrive, acquista un significato densissimo. Il passato romano qui non ha spazio, non perché egli non appartenga a quel mondo, ma perché percepisce che ora altre strade devono essere battute. In Gregorio si corona una linea non marginale del cristianesimo occidentale, che inizia con l’Agostino del De civitate e con Salviano di Marsiglia: la linea che percepisce che il cristianesimo non è posto nella storia per salvare gli imperi, anche se questi si dicono cristiani. L’obbiettivo della Chiesa non dovrà essere la salvaguardia di un mondo pur di grandiosa tradizione, ma confessare la grandezza delle opere compiute dal Signore o di quelle che ancora attendono di manifestarsi. In Gregorio, la politica ecclesiale si fa prepotentemente profezia.
Il mondo antico con lui può davvero dirsi finito. Alla Chiesa del VII sec. si aprono le lande sconfinate delle popolazioni germaniche, che già manifestano i segni della ricerca di un’integrazione con il mondo latino. Saranno altri a raccogliere e a far fruttare quei semi, e lo faranno nel nome del Signore. A Gregorio spetta incontestabile il merito di aver intravisto il futuro della Chiesa. Per dirla con il vocabolario missionario usato dallo stesso Gesù: a Gregorio va riconosciuto il merito grande di aver saputo vedere la messe biondeggiare. E non è, davvero, poca cosa.