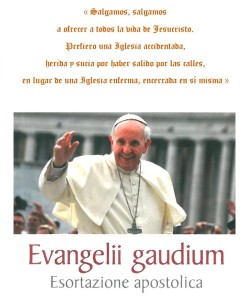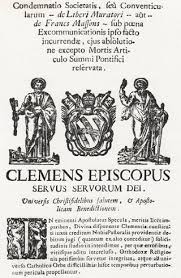Non sempre chi parla ha qualcosa da dire, e proverbi a grappolo
 di Carlo Nardi • Ogni cosa a suo tempo. “Avreste potuto anche dir l’avemmaria: questa è l’ora di stare attenti alla lezione”. Così la professoressa di francese a due mie compagne di ginnasio in fondo alla classe non solo un po’ chiacchierine, ma anche bell’e pronte a giustificare il loro cinguettare con un “ma si parlava di cose serie”.
di Carlo Nardi • Ogni cosa a suo tempo. “Avreste potuto anche dir l’avemmaria: questa è l’ora di stare attenti alla lezione”. Così la professoressa di francese a due mie compagne di ginnasio in fondo alla classe non solo un po’ chiacchierine, ma anche bell’e pronte a giustificare il loro cinguettare con un “ma si parlava di cose serie”.
Si potrebbe dire con il Sapiente biblico, il Qoelet o Ecclesiaste, come dir si voglia, e col proverbio comune: Ogni cosa a suo tempo. Perché non ci si mette a parlare di geometria a un funerale, dicevano i greci, e non si mescola il sacro col profano … senza il bisogno di scomodar le quarantore e qualcos’altro. E non solo ogni cosa a suo tempo, bensì anche da parte di chi quella cosa la deve fare o dare: si direbbe da parte di chi ha competenza, di chi è competente, parole che oggi in italiano mi pare abbiano soprattutto due significati vicini, ma non equivalenti.
E a ciascuno il suo. Competente è infatti colui che può e deve dare o fare quello che deve dare e fare nell’ambito dei rapporti umani, in senso anche giuridico, perché quella cosa gli compete: si parla in questo senso di ‘autorità’, di ‘ufficio competente’. Ma competente – è l’altro significato – è anche colui che sa quello che deve sapere o fare: appunto il competente in materia.
D’altra parte, anche questo secondo significato s’avvicina al primo. Sapere quello che si deve sapere è correttezza nei rapporti, è coscienza professionale, è onestà intellettuale: è stare semplicemente alla parola data, per rimanere sul lato positivo, ché del risvolto negativo ne è pieno il mondo … di parecchio fumo, quando va relativamente bene. E in questo ambito un proverbio o un modo di dire tira l’altro. Li rammento, quelli che mi vengono in mente. Si comincia dal Rubar con gli occhi in ossequio a Impara l’arte e mettila da parte, con la consapevolezza che L’arte è lunga, la vita breve, per non ritrovarsi senz’arte né parte e di conseguenza Cento mestieri: un soldo, più che mai tristemente attuale, a differenza invece di chi sa il fatto suo, perché sa il suo mestiere o almeno ci ha naso e trova il modo di cavarci le gambe nelle situazioni e nei problemi sempre nuovi.
A scuola dal vecchio Socrate. Onestà intellettuale è anche la lezione del vecchio Socrate, tutto intento a domandare a chi diceva di sapere se era in grado di rendere conto del sapere che diceva di avere. S’era in un periodo – solo allora? – in cui si pretendeva di far passare per valido anche un discorso che in sé non avesse … né capo né coda: insomma, ci si faceva belli nel menare elegantemente per il naso la gente. Si cimentavano in questo alcuno tra i cosiddetti sofisti. Del resto, la parola “sofisticato” viene dal greco di allora, dall’Atene del quarto secolo a.C. E quand’è che un discorso è “sofisticato”? Quando chi l’ha sentito ti dice: “bello!”, ma se gli domandi: “ma che ha detto?”, ti risponde: “bo?!”.
Invece Socrate andava alla ricerca di tí légein, letteralmente “dire qualcosa”, qualcosa di sensato, qualcosa che è, e di conseguenza era alla ricerca “che cos’è” (tí estin) quello di cui si parla. Eh, sì: perché non sempre chi parla ha qualcosa da dire. Un altro proverbio, che sentii dire proprio dal direttore di questa Rivista, don Andrea Drigani – eravamo qualche anno fa in seminario -, e che mi è rimasto impresso nella mente con una certa mestizia che il detto porta con sé.
Ancora. Di fronte alla fiducia nelle forze più o meno occulte della persuasione, fiducia che facilmente si ribalta in complesso d’inferiorità, con un po’ dello spirito dell’antico Socrate, e soprattutto di Quello di Nostro Signore, anche san Paolo mette al bando «i ragionamenti persuasivi escogitati da accortezze umane». Potrebbero essere esche utili per mandare in paradiso? No, risulta rispondere san Paolo nella Prima lettera ai Corinzi: no, per il rispetto di Colui che ci manda a parlare; e poi un altro no, perché nessuno neppure con le migliori intenzioni è da prendere per il naso.
In compagnia dei magi. Un richiamo all’onestà intellettuale, che vuole affrontare sul serio le cose, è più che mai opportuno da farci a tu per tu con la nostra coscienza, e non solo tra i buoni propositi d’inizio d’anno. Vuol dire rispettare l’opera di Dio che nella Genesi insegna anche a noi a distinguere le cose e gli ambiti. È la lezione dell’antica Lettera a Diogneto e, vicina a noi, della Gaudium et spes che richiamano alla fedeltà – anche qui la parola data -, al compito, altra parola imparentata con “competenza”, personale, ma anche in una trama di rapporti. Come alla lezione di francese, a cui stare attenti.
I magi, per quei tempi competenti in materia, presero sul serio l’avvistamento di una stella o di che cosa fu, che comunque era lo spunto, l’elemento che avevano a disposizione, peraltro muto. Non avevano di più, non avevano di meno. Da parte loro, videro, valutarono, agirono. Osservarono, giudicarono, decisero. Con competenza, decisione e tenacia misero in conto un rischio ragionevole, anche quello del ridicolo di chi fa un viaggio a vuoto, e comunque il rischio di dover rivedere di sana pianta le loro competenze. Se però non avessero messo in atto le competenze che avevano, non avrebbero trovato Chi effettivamente trovarono.