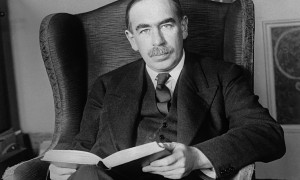di Francesco Romano • L’arbitrato storicamente è un istituto che affonda le sue radici nella cultura primitiva, alle origini delle relazioni giuridiche tra gli uomini quando ancora iniziavano a orientarsi verso le prime forme di civile convivenza per risolvere le controversie, non più fondate sulla forza o regolate dalla vendetta, ma ricorrendo a una figura terza scelta dalle parti per comporre la disputa.
di Francesco Romano • L’arbitrato storicamente è un istituto che affonda le sue radici nella cultura primitiva, alle origini delle relazioni giuridiche tra gli uomini quando ancora iniziavano a orientarsi verso le prime forme di civile convivenza per risolvere le controversie, non più fondate sulla forza o regolate dalla vendetta, ma ricorrendo a una figura terza scelta dalle parti per comporre la disputa.
Una forma di arbitrato è possibile rinvenirla nella controversia indotta dalla dea della discordia. Paride fu chiamato da Zeus come arbitro per dirimere la controversia su chi fosse, tra Era, Atena e Afrodite, la più bella e attribuirle il pomo lanciato da Eris, la dea discordia. La terzietà nella scelta di Paride fu voluta da Zeus nonostante lui stesso fosse legittimato nel giudizio.
L’arbitrato sorge come evoluzione della società primitiva che rinuncia al regime di vendetta privata per sottomettere le liti al giudizio di una persona della comunità più qualificata per virtù e onestà denominata arbitro o conciliatore, scelta di comune accordo dai contendenti. Una delle tappe del progresso sociale è stata l’abbandono dell’uso della forza e il passaggio dalla giustizia privata alla giustizia arbitrale.
Platone riguardo alle controversie sorte sul possesso dei beni o sul comportamento di uno schiavo emancipato ritiene che “i processi per costoro siano di competenza dei tribunali e delle tribù, a meno che le parti non pongano fine alle imputazioni reciproche presso dei vicini o dei giudici da loro scelti” (Platone, Le leggi, Dialogo XI).
Secondo Seneca l’arbitro, a differenza del giudice, può decidere ancor prima che secondo legge e giustizia, con umanità e misericordia “non prout lex aut iustitia, sed prout humanitas aut misericordia regere” (Seneca, De beneficiis, 3.7.5).
Per Aristotele è meglio “preferire un arbitro piuttosto che una lite in tribunale, infatti l’arbitro bada all’equità, il giudice alla legge. L’arbitrato è stato inventato proprio per questo, per dar forza all’equità” (Aristotele, Rhetorica, 1.13.13).
Un esempio di giustizia arbitrale è descritto nel libro dell’Esodo per regolamentare la richiesta di risarcimento del danno senza cadere nella vendetta personale: “Quando alcuni uomini rissano e urtano una donna incinta, così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, si esigerà un’ammenda, secondo quanto imporrà il marito della donna, e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato” (Es 21, 22).
Nel Libro della Genesi un esempio di arbitrato lo si trova nel rimprovero di Giacobbe a Labano che lo accusa di essersi impossessato dei suoi idoli, in realtà trafugati da Rachele a sua insaputa. Per cui Giacobbe dice a Labano: “Ora che hai frugato tra i miei oggetti, che hai trovato di tutte le robe di casa tua? Mettilo qui davanti ai miei e tuoi parenti e siano essi giudici tra noi due” (Gen 31, 37). Troviamo anche Mosè arbitro nelle controversie tra capi di famiglia: “Mosè rispose al suocero: “Perché il popolo viene da me per consultare Dio. Quando hanno qualche questione, vengono da me e io giudico le vertenze tra l’uno e l’altro e faccio conoscere i decreti di Dio e le sue leggi” (Es 18, 16).
Nel Vangelo possiamo rinvenire un esempio di arbitrato nella richiesta rivolta a Gesù di dirimere una controversia sorta tra due fratelli sull’eredità da dividere: “Uno della folla gli disse: «Maestro, dì a mio fratello che divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» (Lc 12, 13-14). Sotto l’aspetto strettamente giuridico la risposta di Gesù solleva una questione di legittimità sulla richiesta che gli viene rivolta in quanto nell’arbitrato sono entrambe le parti in causa che scelgono di comune accordo uno che sia al di sopra per dirimere la controversia. In realtà Gesù vuole appellarsi al fondamento biblico nella distinzione tra giustizia temporale giustizia spirituale.
San Paolo nella prima lettera ai Corinti (1 Cor 6, 2-9) ha presente l’istituto dell’arbitrato e lo indica come soluzione per dirimere le controversie sorte tra i cristiani di quella Chiesa anziché ricorrere ai tribunali civili. è preferibile subire l’ingiustizia e lasciarsi privare di ciò che un cristiano possiede piuttosto che trascinare il fratello nella fede in giudizio e per giunta davanti a giudici pagani. Il ricorso dovrebbe essere rivolto alla comunità dove poter trovare giustizia. Per questo San Paolo pone in senso interlocutorio la domanda: “non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa far da arbitro tra fratello e fratello? No, anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a infedeli!” (1 Cor. 6, 5-6).
San Paolo, nel rivolgersi ai Corinti propone il ricorso all’arbitrato essendo un istituto presente nell’ordinamento giuridico ellenico del tempo. Quindi, la funzione dell’arbitro scelto all’interno della comunità risponde all’esigenza di risolvere in via ordinaria le controversie sul piano temporale, non per particolare diffidenza sull’onestà dei giudici pagani. Per altro, proprio San Paolo esorta i cristiani a stare sottomessi all’autorità (Rm 13, 1-7). I magistrati pagani non possiedono la giustizia conferita da Dio, mentre l’arbitro scelto nella comunità tra i fratelli agisce come fratello nella fede, al rigor iuris fa prevalere l’aequitas cristiana in un connubio tra verità, giustizia e misericordia.
San Paolo rimane silente circa la composizione delle liti tra cristiani e pagani ed è evidente che in questi casi dovesse prevalere la giurisdizione laica pagana, non senza fare un tentativo di composizione della lite ricorrendo a una sorta di recuperator, un arbitro cristiano sul modello di figure analoghe conosciute nel diritto romano.
In epoca medievale l’istituto dell’arbitrato prende forma nella episcopalis audientia. I fedeli godevano della facoltà di sottoporsi al giudizio del Tribunale del Vescovo da loro eletto a essere arbitro nelle liti, anziché ricorrere alla magistratura statale, marcando verso di esso una maggiore fiducia rispetto alla struttura pubblica.
Da quanto detto, la Chiesa cattolica fin dalle origini, ma soprattutto nell’epoca del diritto comune, ha favorito il ricorso al sistema arbitrale non solo come figura terza per risolvere nelle vesti di arbitro le controversie, ma anche nelle liti in questioni di natura civile divenendo spesso l’arbitrato vescovile una procedura previa prima di fare ricorso alla giustizia ordinaria. L’arbitrator, con potestà diversa dalla iurisdictio del giudice, era un compositore della lite che risolveva in via equitativa ex bono et aequo in un ambito di natura privatistica. L’arbiter, invece, con potere prossimo alla iurisdictio del giudice, doveva procedere secondo le formalità del giudizio ordinario secundum iudiciorum ordinem.
Come era avvenuto dopo la caduta dell’impero romano, attraverso l’istituto dell’arbitrato si vede la continuità dell’organizzazione statale che fa propria la tradizione giuridica romanista fino a entrare nell’ordinamento canonico. Anche in età moderna negli Stati protestanti europei la tradizione giuridica romanista continuò a sopravvivere per la presenza di missionari cattolici che si avvalevano della normativa canonica nell’esercizio del loro apostolato.
Le definizioni arbitrali con frequenza crescente sostituivano le sentenze dei magistrati. L’arbitro godeva di una potestà delegata svolgendo una funzione analoga a quella ordinaria del giudice.
Parallelamente, con l’affermazione delle corporazioni professionali di commercianti e artigiani si estende anche il fenomeno arbitrale come alternativa alla giurisdizione statale. Tuttavia, a differenza di quanto accedeva nel diritto romano, essendo l’arbitrato imposto ex lege, la decisione arbitrale detta laudum, doveva fondarsi sul diritto piuttosto che sull’arbitrium e trovare omologazione con l’exequatur da parte del giudice pubblico.
L’esercizio dell’arbitrato conosce un declino con l’assolutismo, mentre la funzione giudiziale rimane prerogativa dello Stato moderno. Tuttavia, l’arbitrato non ha cessato mai fino ai nostri giorni in tutti i sistemi giuridici di essere strumento efficace per dirimere le controversie.
Il vigente Codice di Diritto Canonico conosce l’istituto dell’arbitrato affidato all’ufficio del giudice: “Se la lite verte su interessi privati delle parti, il giudice consideri se la controversia possa avere fine utilmente mediante la transazione o il giudizio arbitrale, a norma dei cann. 1713-1716” (can. 1446 §3). Il Legislatore canonico indica quale modo per evitare i giudizi il ricorso al compromesso arbitrale: “Per evitare le liti giudiziarie, si può ricorrere utilmente alla transazione o conciliazione, oppure si può sottoporre la controversia al giudizio di uno o più arbitri” (can. 1713).
Con l’arbitrato le parti in lite sottoscrivono un contratto con l’intento di affidare la decisione della controversia a terze persone, cioè a giudici privati detti arbitri.
La transazione, che può essere giudiziaria o extragiudiziaria, è invece un contratto che le parti sottoscrivono facendosi reciproche concessioni allo scopo di prevenire o porre termine a una lite già iniziata. A questo proposito vengono in mente le parole di Gesù: “Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione” (Mt 5, 25); “A chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello” (Mt 5, 40).
L’arbitrato, quindi, è un istituto giuridico che entra nella storia dell’umanità accompagnandola nel lungo percorso di civilizzazione, nel passaggio dalla giustizia privata, dalla risoluzione dei conflitti come vendetta personale all’individuazione di alcune regole per dirimere la disputa affidata dai contendenti a un arbitro o conciliatore. La giustizia arbitrale si rivela come prima necessità dell’uomo nello stabilire relazioni sociali fondate sulla convivenza pacifica, nel passare dal mondo dell’uomo selvaggio verso la civilizzazione, nel percepire di alcuni principi primi della giustizia come li ha enucleati Ulpiano: “iuris praecepta sunt honeste vivere, alterum non laedere, suumque tribuere” (Ulpiano, Regole, D. 1.1.10 pr.).
L’evolversi della giustizia arbitrale inizia il suo percorso nella mitologia come memoria delle civiltà antiche di avvenimenti realmente accaduti. L’arbitrato lo troviamo presente nella sacra pagina dell’Antico e Nuovo Testamento, nell’ordinamento giuridico romano e successivamente nell’ordinamento canonico. La funzione giudiziaria è propria dello Stato moderno, ma l’arbitrato continua a sopravvivere fino ai nostri giorni per risolvere pacificamente le controversie senza procedimento giudiziario ricorrendo a un soggetto terzo.
 Andrea Drigani ricorda il cardinale Josef Beran, nel 50° della morte, un martire ed un difensore della libertà religiosa, che dette un contributo assai importante, durante i lavori del Vaticano II, per la stesura della Dichiarazione «Dignitatis Humanae». Francesco Romano richiama l’antico istituto dell’arbitrato, già disciplinato sia nella Bibbia che nel diritto romano, che continua ad esistere nell’ordinamento canonico e civile, ed esprime la volontà di risolvere pacificamente le controversie nel rispetto delle regole. Mario Alexis Portella compie una disamina sull’attuale equilibrio mondiale, incentrato sugli USA, la Cina e la Russia, che appare alquanto incerto ed instabile, ben lontano da quella pace che San Paolo VI vedeva fondata solo sul diritto e la giustizia. Dario Chiapetti con il volume di Irénée Hauscher illustra la tradizione esicasta, che non è solo un modello per monaci, ma può esserlo per ogni cristiano, perché nel distacco dal mondo si abbraccia il mondo. Giovanni Campanella ripropone una recente edizione di alcuni scritti di John Maynard Keynes (1883-1946), che suscita ancora interesse per le sua posizioni, in quanto appaiono una sintesi delle migliori indicazioni di politica economica, contro gli eccessi e gli estremismi. Antonio Lovascio col Messaggio per la LII Giornata Mondiale della Pace, presenta le indicazioni del Papa sull’urgenza di una «buona politica», presupposto fondamentale per ogni convivenza pacifica. Gianni Cioli ribadisce l’assoluta importanza di un adeguato annuncio cristiano sulla morte nell’evangelizzazione e nella catechesi, anche con il saggio uso degli eufemismi. Francesco Vermigli dal discorso di Papa Francesco per gli auguri natalizi alla Curia Romana annota sulle luci e le ombre nella vita della Chiesa, da qui la necessità di una costante e continua conversione, secondo l’antico detto: «Ecclesia semper reformanda». Alessandro Clemenzia recensisce il volume di Maria Licia Paglione che si sofferma sull’espressione «bene relazionale», per la quale tutte le relazioni umane, per essere veramente tali, sono da costruirsi sulla reciprocità e sulla gratuità. Leonardo Salutati si diffonde sul concetto di «periferie esistenziali» da intendersi in riferimento a tutti coloro che si sono allontanati da Dio o che lo cercano, verso i quali va promossa una grande opera di evangelizzazione che orienta sempre verso un’azione trasformante della storia. Stefano Liccioli fa memoria dei quaranta missionari uccisi nel 2018, si tratta del sacrificio di sacerdoti, religiosi e laici che hanno offerto la loro testimonianza cristiana di amore e di servizio, denunciando il male e l’ingiustizia. Giovanni Pallanti rammenta l’Appello ai «liberi e forti», lanciato cento anni fa da Don Luigi Sturzo, che portò alla fondazione del Partito Popolare Italiano e segnò l’inizio della storia della presenza politica dei cattolici democratici. Carlo Nardi sviluppa alcune considerazioni sulla competenza storiografica di San Luca, che riprende la metodologia medica: vedere, valutare, agire.
Andrea Drigani ricorda il cardinale Josef Beran, nel 50° della morte, un martire ed un difensore della libertà religiosa, che dette un contributo assai importante, durante i lavori del Vaticano II, per la stesura della Dichiarazione «Dignitatis Humanae». Francesco Romano richiama l’antico istituto dell’arbitrato, già disciplinato sia nella Bibbia che nel diritto romano, che continua ad esistere nell’ordinamento canonico e civile, ed esprime la volontà di risolvere pacificamente le controversie nel rispetto delle regole. Mario Alexis Portella compie una disamina sull’attuale equilibrio mondiale, incentrato sugli USA, la Cina e la Russia, che appare alquanto incerto ed instabile, ben lontano da quella pace che San Paolo VI vedeva fondata solo sul diritto e la giustizia. Dario Chiapetti con il volume di Irénée Hauscher illustra la tradizione esicasta, che non è solo un modello per monaci, ma può esserlo per ogni cristiano, perché nel distacco dal mondo si abbraccia il mondo. Giovanni Campanella ripropone una recente edizione di alcuni scritti di John Maynard Keynes (1883-1946), che suscita ancora interesse per le sua posizioni, in quanto appaiono una sintesi delle migliori indicazioni di politica economica, contro gli eccessi e gli estremismi. Antonio Lovascio col Messaggio per la LII Giornata Mondiale della Pace, presenta le indicazioni del Papa sull’urgenza di una «buona politica», presupposto fondamentale per ogni convivenza pacifica. Gianni Cioli ribadisce l’assoluta importanza di un adeguato annuncio cristiano sulla morte nell’evangelizzazione e nella catechesi, anche con il saggio uso degli eufemismi. Francesco Vermigli dal discorso di Papa Francesco per gli auguri natalizi alla Curia Romana annota sulle luci e le ombre nella vita della Chiesa, da qui la necessità di una costante e continua conversione, secondo l’antico detto: «Ecclesia semper reformanda». Alessandro Clemenzia recensisce il volume di Maria Licia Paglione che si sofferma sull’espressione «bene relazionale», per la quale tutte le relazioni umane, per essere veramente tali, sono da costruirsi sulla reciprocità e sulla gratuità. Leonardo Salutati si diffonde sul concetto di «periferie esistenziali» da intendersi in riferimento a tutti coloro che si sono allontanati da Dio o che lo cercano, verso i quali va promossa una grande opera di evangelizzazione che orienta sempre verso un’azione trasformante della storia. Stefano Liccioli fa memoria dei quaranta missionari uccisi nel 2018, si tratta del sacrificio di sacerdoti, religiosi e laici che hanno offerto la loro testimonianza cristiana di amore e di servizio, denunciando il male e l’ingiustizia. Giovanni Pallanti rammenta l’Appello ai «liberi e forti», lanciato cento anni fa da Don Luigi Sturzo, che portò alla fondazione del Partito Popolare Italiano e segnò l’inizio della storia della presenza politica dei cattolici democratici. Carlo Nardi sviluppa alcune considerazioni sulla competenza storiografica di San Luca, che riprende la metodologia medica: vedere, valutare, agire.