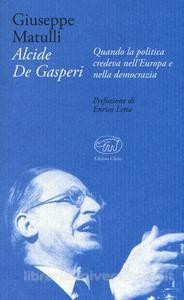di Gianni Cioli • Nel libro Poesia come profezia. Una lettura di Alda Merini (Effatà editrice, Cantalupa, TO), pubblicato nel 2008, quando la poetessa, scomparsa nel 2009, era ancora vivente, Chiara Saletti, laureata in lettere moderne presso l’Università di Padova e socia del Coordinamento teologhe italiane, coniuga felicemente le proprie competenze letterarie con quelle teologiche proponendo una coinvolgente interpretazione degli scritti meriniani, particolarmente attenta a cogliere anche – in sintonia con gli interessi guida della collana «Sui generis» che ospita il saggio – un modo peculiarmente femminile di dire Dio.
di Gianni Cioli • Nel libro Poesia come profezia. Una lettura di Alda Merini (Effatà editrice, Cantalupa, TO), pubblicato nel 2008, quando la poetessa, scomparsa nel 2009, era ancora vivente, Chiara Saletti, laureata in lettere moderne presso l’Università di Padova e socia del Coordinamento teologhe italiane, coniuga felicemente le proprie competenze letterarie con quelle teologiche proponendo una coinvolgente interpretazione degli scritti meriniani, particolarmente attenta a cogliere anche – in sintonia con gli interessi guida della collana «Sui generis» che ospita il saggio – un modo peculiarmente femminile di dire Dio.
Poiché la produzione di Alda Merini è molto vasta e la matrice religiosa attraversa tutta la sua opera, la Saletti, pur tenendo presente l’intero orizzonte della poesia meriniana, ha «ritenuto necessario limitare l’attenzione a tre raccolte a tema religioso, scritte a breve distanza l’una dall’altra e risultanti quindi omogenee e in continuità tra loro: (…) Corpo d’amore. Un incontro con Gesù (2001), Magnificat. Un incontro con Maria (2002), Poema della croce (2004)» (p. 8).
Il libro si articola in due parti, precedute da un’Introduzione e da un’opportuna scheda su La vita e le opere della poetessa milanese.
Nell’Introduzione l’autrice sintetizza le proprie linee interpretative e illustra in particolare il concetto di comprensione come categoria teologica: «Dio si fa presente laddove sembra non ci siano più speranze, dove la nostra presunzione ha ceduto il passo, dove sopravviviamo, nudi con i nostri mali; e si fa presente, come colui “che ha sofferto le carni della donna e dell’uomo” (Corpo d’amore. Un incontro con Gesù, Milano 2001, 34), che sa la tentazione, il dubbio, la paura, che conosce il bisogno di conforto, lo smarrimento di chi sta per soccombere: in una parola come colui che comprende» (p. 6).
Nella prima parte, intitolata La poesia della parola. Parte antologica, attraverso la scelta e la presentazione di brani poetici, viene presentato con efficacia il profilo di Maria tracciato dalla Merini, mettendo in evidenza la capacità della poetessa di evocarne «l’interiorità, lo stupore, lo sforzo compiuto per l’accettazione del progetto di Dio su di lei; Maria narrata nei suoi sentimenti di madre e di adolescente innamorata dell’amore, Maria sospesa tra cielo e terra, tra io e Dio». Accanto a quella della madre, la Saletti presenta anche la figura di Gesù quale emerge dai versi meriniani, «ugualmente in precario equilibrio tra il prorompente e umanissimo richiamo della terra e degli affetti e la scoperta del suo rapporto con il Padre».
Nella poesia della Merini Maria e Gesù appaiono «quali volti umani dell’amore di Dio, e i loro percorsi esistenziali sono narrati con tutta la profondità e la complessità che li connota e accomuna» (p. 9).
Nella seconda parte, intitolata La parola della poesia. Tracce di lettura sintetica, l’autrice mette a confronto l’esperienza di fede che emerge dalla poesia meriniana «con la specificità del Dio cristiano, cercando di individuare le linee portanti del pensiero religioso di Alda Merini in rapporto anche allo sforzo di “dire Dio” da parte delle donne credenti e della loro teologia». Questo non tanto perché – sottolinea la Saletti nell’introduzione – «Alda Merini si collochi in un’area di pensiero “femminista” (pur prendendo il termine nella sua accezione più ampia ed onnicomprensiva), tutt’altro! Ma perché crediamo che vi sia una modalità appunto “al femminile”, di annunciare Dio, di vivere la relazione con Lui, che partendo dalla parzialità di genere abbia un suo contributo da portare; una modalità che si intreccia con le esperienze feriali, quotidiane in cui le donne si trovano a vivere e in cui hanno saputo declinare la loro fede». Quella della Merini «è appunto l’esperienza di una donna, di un dolore, di una vita, di un cammino, di una scoperta, di una gioia (ri)trovata, all’interno della quale Dio c’entra sempre».
«Dio Padre, Gesù il figlio-uomo, e Maria sua madre si offrono così nelle liriche» di Alda Merini – sottolinea ancora l’autrice – «come nuova possibilità donata a tutti, uomini e donne del secondo millennio, di riscoprire un Dio che non cessa di rinnovarsi, di incontrarci, di rispondere ai dubbi e alle paure nascoste nel nostro piccolo cuore» (p. 9).
Alla seconda parte segue un ulteriore capitolo, Tra poesia e teologia, che la Saletti definisce come «il tentativo di legittimazione del linguaggio poetico quale strumento idoneo al dire e al dirsi di Dio». Secondo l’autrice «il Dio cristiano si identifica come il Dio della Parola perché attraverso di essa fa essere ciò che non è, evoca suscita, comunica, interpella (…). Ed è quella stessa Parola adottata da Dio per uscire da sé e incontrare l’uomo, che si apre nella poesia alla rivelazione del mistero divino, che permette all’uomo di percorrere a ritroso il cammino ascendente per l’incontro con il suo Dio» (p. 10).
Nella Conclusione l’autrice conferma il suggestivo concetto evocato dal titolo del libro, applicabile alla poesia in generale e a quella meriniana in particolare: «Parola poetica dunque come parola profetica, come parola perfettamente umana che sappia tener vive tutte le necessarie domande su Dio e sull’uomo, che possa ridire in mille modi il bisogno di essere amati e di amare, che canti ancora una volta la fatica di un senso, di un significato ritrovato, perché nulla di ciò che è umano può andare perduto» (p. 106).
Oltre che dalla Bibliografia essenziale, suddivisa in «Testi di Alda Merini», «Studi» e «Articoli», il libro viene completato dalla postfazione (Il Verbo si fece carne: la poesia di Alda Merini) di Marco Campidelli, teologo e cultore di poesia, personalmente amico della poetessa, il quale afferma la necessità di una reciproca compenetrazione tra teologia poesia: «Teologia e poesia, ognuna nel suo verso, sono un modo di prendersi cura di Dio e di prendersi cura del mondo. Due alleate che non dovrebbero mai lasciarsi, soprattutto quando la notte si infittisce. Si dice spesso che vi sia crisi della politica. Penso, in verità, che vi sia principalmente la crisi della poetica, ovvero di orizzonte, di visione, di rivelazione. Camminare sul filo della poesia ci aiuterà dunque a trovare il senso di stare in questo mondo lacerato, trafitto, ma non privo di canto e di danza, prendendocene amorosamente cura» (p.125).
Il saggio, breve ma profondo, di Chiara Saletti ha due grandi meriti: contribuire a far apprezzare una poesia di grande bellezza e raffinatezza, come quella di Alda Merini, e sperimentare un metodo di lettura della poesia in chiave teologica dal quale la teologia potrà trarre sicuramente giovamento, nell’auspicio che il dialogo fra riflessione teologica e produzione poetica, letteraria e artistica possa intensificarsi sempre di più.
 Andrea Drigani dall’ultimo Discorso di Papa Francesco al Tribunale della Rota Romana propone alcune considerazioni sulla coscienza dei giudici ecclesiastici e dei confessori, anche in ordine alla formazione di una coscienza cristiana. Francesco Vermigli fa memoria, nel cinquantesimo anniversario della morte, di Hugo Rahner, storico del cristianesimo antico e patrologo, fratello del più famoso Karl, i cui metodi teologici potrebbero sembrare alternativi e concorrenti, mentre possono essere complementari e coesistenti. Giovanni Campanella prende spunto dal libro di Emanuele Felice sulla storia economica della felicità, per riproporre il senso genuino di quest’ultima alla luce della rivelazione cristiana. Francesco Romano con il volume di Paolo Grossi riflette sull’«inventio» del diritto, nel significato latino della parola che esprime l’azione di trovare, osservando che l’ordinamento giuridico non è frutto del potere creativo politico, bensì ricerca nel profondo della storia. Dario Chiapetti dallo studio di Roberto Repole sull’ecclesiologia di Papa Francesco, annota sul relativismo «pratico» conseguente a quello «teorico», nonchè sull’autentica nozione di popolo di Dio che esclude ogni forma di populismo. Mario Alexis Portella fa presente che la tutela dei diritti umani nel mondo, che ha ispirato la fondazione degli Stati Uniti d’America, come pure affermò Benedetto XVI, sembra alquanto appannarsi dalle ultime decisioni della politica americana. Stefano Tarocchi sull’esempio di San Paolo invita a considerare il ministero apostolico come dimensione di servizio e di apertura verso tutti. Leonardo Salutati indica, tenendo conto del Magistero della Chiesa, come la strategia della dissuasione nucleare sia da ritenersi inammissibile per la salvezza dell’intera famiglia umana. Gianni Cioli recensisce il libro di Chiara Saletti sulla poetessa Alda Merini, dal quale emerge l’importanza del linguaggio poetico quale strumento idoneo al dire e al dirsi di Dio. Carlo Parenti richiama l’attenzione sull’uso etico di internet partendo da alcuni frasi dei grandi magnati della tecnologia digitale. Antonio Lovascio affronta la questione, denunciata dall’Istat e fonte di preoccupazione per il mondo cattolico, del grave fenomeno della denatalità in Italia che non sembra essere ritenuta una priorità strategica per il futuro. Alessandro Clemenzia riferisce su un convegno svoltosi a Roma inerente al rapporto tra i movimenti ecclesiali, fondati su una dimensione carismatica, e le necessarie forme giuridico-canoniche per lo sviluppo dell’opera di movimenti stessi. Giovanni Pallanti prende l’occasione della recente uscita di due volumi su Alcide De Gasperi, uno di Maria Romana e Paola De Gasperi, l’altro di Giuseppe Matulli, per rinnovare l’attenzione sul grande statista trentino e sulla sua attività politica in Italia e in Europa. Stefano Liccioli intorno alla Giornata mondiale della Gioventù propone due osservazioni fondamentali: l’invito ai giovani a non aver paura, che genera inerzia e desolazione, e la necessità del discernimento che comporta il silenzio della preghiera. Carlo Nardi dinanzi al riemergere di tendenze razziste rammenta i principi della sapienza popolare e il pensiero del teologo domenicano Reginaldo Santilli.
Andrea Drigani dall’ultimo Discorso di Papa Francesco al Tribunale della Rota Romana propone alcune considerazioni sulla coscienza dei giudici ecclesiastici e dei confessori, anche in ordine alla formazione di una coscienza cristiana. Francesco Vermigli fa memoria, nel cinquantesimo anniversario della morte, di Hugo Rahner, storico del cristianesimo antico e patrologo, fratello del più famoso Karl, i cui metodi teologici potrebbero sembrare alternativi e concorrenti, mentre possono essere complementari e coesistenti. Giovanni Campanella prende spunto dal libro di Emanuele Felice sulla storia economica della felicità, per riproporre il senso genuino di quest’ultima alla luce della rivelazione cristiana. Francesco Romano con il volume di Paolo Grossi riflette sull’«inventio» del diritto, nel significato latino della parola che esprime l’azione di trovare, osservando che l’ordinamento giuridico non è frutto del potere creativo politico, bensì ricerca nel profondo della storia. Dario Chiapetti dallo studio di Roberto Repole sull’ecclesiologia di Papa Francesco, annota sul relativismo «pratico» conseguente a quello «teorico», nonchè sull’autentica nozione di popolo di Dio che esclude ogni forma di populismo. Mario Alexis Portella fa presente che la tutela dei diritti umani nel mondo, che ha ispirato la fondazione degli Stati Uniti d’America, come pure affermò Benedetto XVI, sembra alquanto appannarsi dalle ultime decisioni della politica americana. Stefano Tarocchi sull’esempio di San Paolo invita a considerare il ministero apostolico come dimensione di servizio e di apertura verso tutti. Leonardo Salutati indica, tenendo conto del Magistero della Chiesa, come la strategia della dissuasione nucleare sia da ritenersi inammissibile per la salvezza dell’intera famiglia umana. Gianni Cioli recensisce il libro di Chiara Saletti sulla poetessa Alda Merini, dal quale emerge l’importanza del linguaggio poetico quale strumento idoneo al dire e al dirsi di Dio. Carlo Parenti richiama l’attenzione sull’uso etico di internet partendo da alcuni frasi dei grandi magnati della tecnologia digitale. Antonio Lovascio affronta la questione, denunciata dall’Istat e fonte di preoccupazione per il mondo cattolico, del grave fenomeno della denatalità in Italia che non sembra essere ritenuta una priorità strategica per il futuro. Alessandro Clemenzia riferisce su un convegno svoltosi a Roma inerente al rapporto tra i movimenti ecclesiali, fondati su una dimensione carismatica, e le necessarie forme giuridico-canoniche per lo sviluppo dell’opera di movimenti stessi. Giovanni Pallanti prende l’occasione della recente uscita di due volumi su Alcide De Gasperi, uno di Maria Romana e Paola De Gasperi, l’altro di Giuseppe Matulli, per rinnovare l’attenzione sul grande statista trentino e sulla sua attività politica in Italia e in Europa. Stefano Liccioli intorno alla Giornata mondiale della Gioventù propone due osservazioni fondamentali: l’invito ai giovani a non aver paura, che genera inerzia e desolazione, e la necessità del discernimento che comporta il silenzio della preghiera. Carlo Nardi dinanzi al riemergere di tendenze razziste rammenta i principi della sapienza popolare e il pensiero del teologo domenicano Reginaldo Santilli.